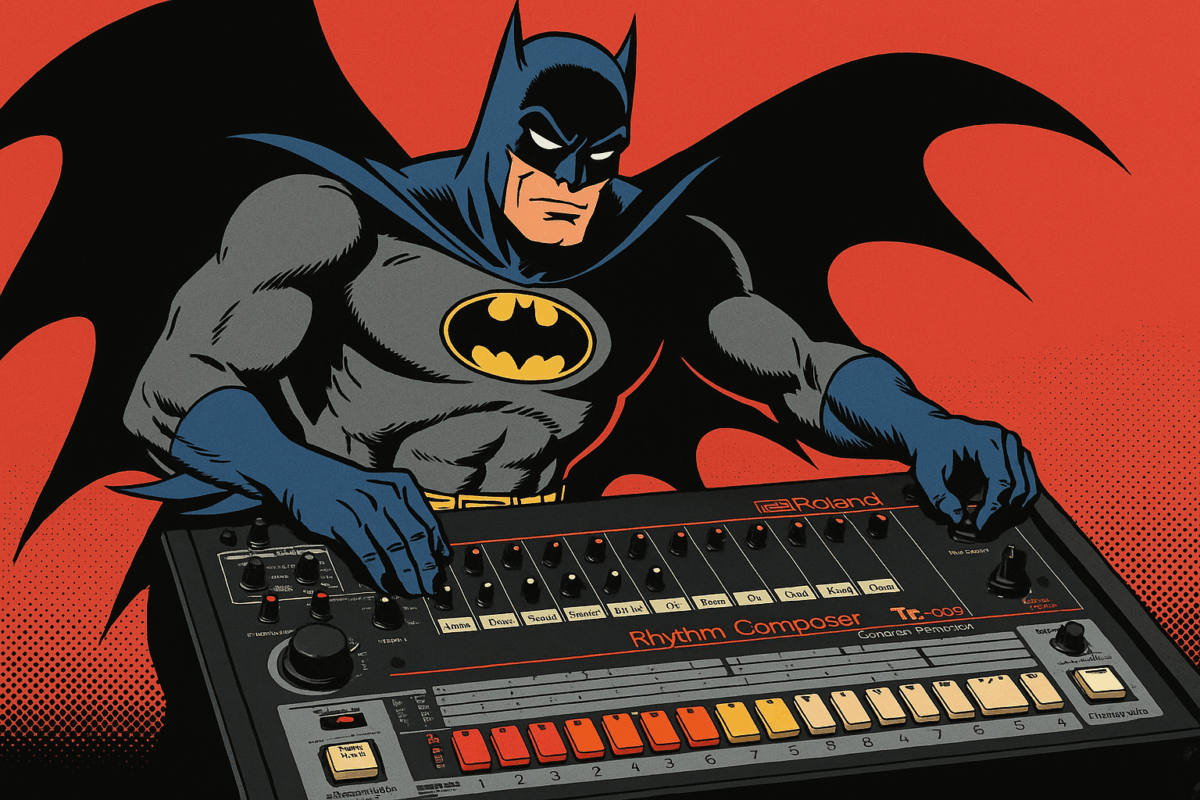La Roland TR-808 Rhythm Composer, affettuosamente chiamata solo “808”, è la drum-machine che ha rivoluzionato la ritmica nella musica moderna.
Chi avrebbe detto che un’apparecchiatura nata all’inizio degli anni ’80 – inizialmente snobbata perché non suonava come una batteria vera – sarebbe diventata il cuore pulsante dell’hip hop, dell’elettronica e di tanti altri generi?
Eppure è andata proprio così: quella scatoletta piena di ritmi dal look grigio con strisce arancioni e gialle ha finito per cambiare il suono di interi decenni.
In questo articolo ripercorriamo la storia della Roland TR-808, dall’idea visionaria del fondatore Ikutaro Kakehashi fino all’impatto culturale globale, rispondendo anche a qualche curiosità: ad esempio che cosa significa “808” nella trap? Chi ha inventato questa drum machine e portato l’hip hop in Italia? Scopriremo inoltre cosa distingue il rap dall’hip hop, e cosa si intende per rap underground (detto anche undie).
Mettetevi comodi: sarà un viaggio tra innovazione tecnologica, rivoluzione musicale e aneddoti curiosi.
Le origini della Roland TR-808: dall’Ace Tone al progetto 808

Per capire come nasce la TR-808 dobbiamo fare un passo indietro. Siamo alla fine degli anni ’70 e Ikutaro Kakehashi – ingegnere giapponese appassionato di musica – ha già una lunga esperienza nel campo degli strumenti elettronici.
Già negli anni ’60, con la sua prima azienda Ace Tone, Kakehashi aveva creato rudimentali drum-machine come la Rhythm Ace FR-1 (1967), un aggeggio che forniva 16 ritmi già pronti grazie a circuiti a transistor e matrici di diodi.
Erano apparecchi pensati per accompagnare organisti e pianisti nelle sale da ballo: più dei “robot batteristi” che dei veri strumenti creativi.
Verso la fine dei ’70 Kakehashi fonda la Roland Corporation e progetta la Roland CR-78, una drum-machine programmabile che offriva ritmi personalizzabili oltre ai preset.
L’idea germinale c’era: perché non costruire una macchina capace di permettere a chiunque di creare la propria sezione ritmica senza dover ingaggiare un batterista umano?
Tuttavia, un problema tecnico e di costi incombeva su questa idea rivoluzionaria: la tecnologia dei campionatori digitali era ancora costosa e acerba.
Salvare suoni di batterie vere in memoria digitale richiedeva chip di memoria con prezzi troppo alti per un prodotto commerciale abbordabile.
Proprio nel 1980 l’americana Linn Electronics Inc. di Roger Linn lanciò sul mercato la Linn LM-1, la prima drum-machine a utilizzare campioni digitali di percussioni reali invece di suoni sintetizzati con transistor e diodi.
La LM-1 era avveniristica – la prima drum-machine ad usare i campioni digitali per i suoni, non prodotti da transistor e diodi ma batterie vere registrate e campionate – ma costava uno sproposito (circa 5.000 dollari).
Si narra che fu il tastierista Steve Porcaro dei Toto a suggerire a Linn l’idea di memorizzare su un chip i suoni di batteria, aspettando che la tecnologia diventasse abbordabile per poi realizzare il prodotto.
La Linn LM-1 introdusse soluzioni innovative come la quantizzazione e lo swing nelle batterie elettroniche, ponendo le basi per strumenti futuri come l’Akai MPC. Ma Kakehashi scelse una strada diversa e più economica per la sua nuova drum-machine Roland: niente campioni digitali, solo circuiti analogici.
In pratica, la TR-808 avrebbe generato i suoi suoni da oscillatori e rumore bianco, sintetizzando grancasse, rullanti e congas invece di riprodurre registrazioni di quelli veri.
Curiosità: a testimonianza dell’approccio “artigianale” e un po’ folle di quei pionieri, si racconta che il crash della TR-808 sia stato accidentalmente creato rovesciando del tè sul circuito durante gli esperimenti!
Il circuito emise un suono simile a un “pssss” frizzante che piacque così tanto ai progettisti da diventare il celebre suono di piatto crash della macchina.
Leggende a parte, era chiaro che la neonata TR-808 puntava su sonorità elettroniche originali più che sul realismo: un rischio calcolato, per evitare le costose memorie digitali e mantenere basso il prezzo finale.
Il lancio della Roland TR-808 sul mercato: un flop annunciato?
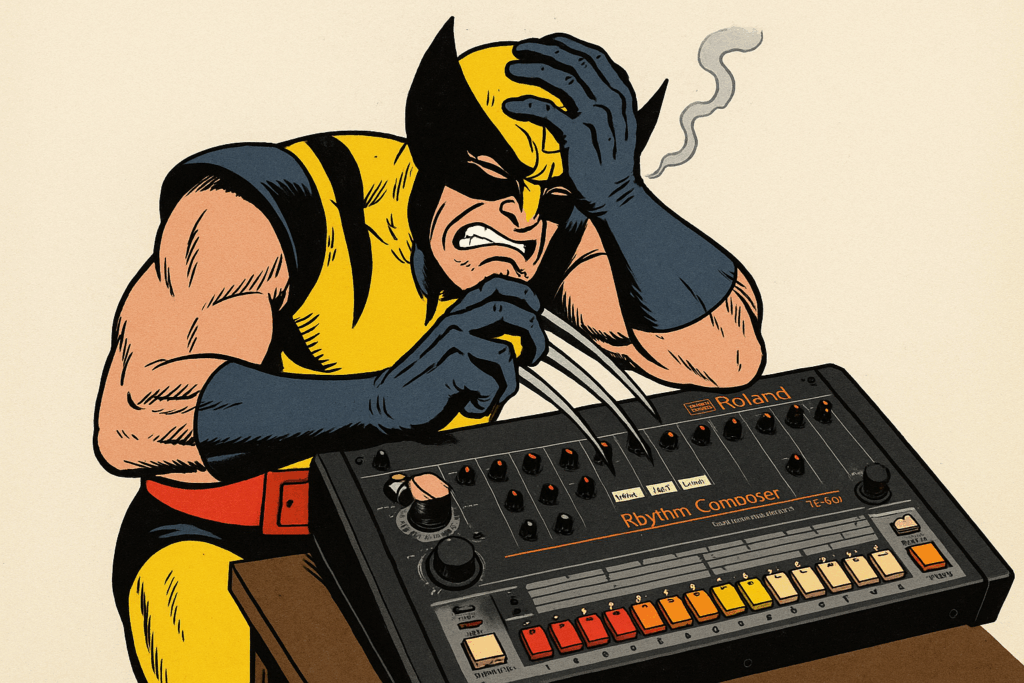
La Roland TR-808 Rhythm Composer debutta nel 1980 a un prezzo di listino di circa 1.195 dollari (in Giappone, circa 120.000 yen). Kakehashi l’aveva immaginata come uno strumento da studio economico per musicisti e produttori: una drum-machine professionale che potesse competere con la blasonata (e carissima) Linn LM-1.
Eppure, nei primi anni, le cose non andarono secondo le aspettative. La Roland TR-808 non suonava bene, dicevano alcuni: quei suoni erano troppo finti, troppo “sintetici”, non suonavano come una batteria vera.
Molti musicisti “seri” dell’epoca la snobbarono, preferendole la concorrente digitale più realistica.
Come se non bastasse, la TR-808 mancava del protocollo MIDI (introdotto solo nel 1983) e quindi non poteva interfacciarsi facilmente con altri strumenti emergenti.
Insomma, la TR-808 sembrava destinata al fallimento o quantomeno a un ruolo di nicchia.
Le vendite inizialmente furono modeste. Complessivamente, della Roland TR-808 ne furono fatti solamente 12.000 esemplari, un numero relativamente basso.
Gli addetti ai lavori dell’epoca guardavano con scetticismo questa scatola rumorosa: “ma è musica questa?”.
Qualcuno alla stessa Roland pare considerasse la 808 un esperimento ormai superato, tanto che la casa la tolse di produzione dopo appena tre anni, nel 1983, per passare al modello successivo (la TR-909).
Molto illuminante è il racconto di come venne percepita all’inizio:
«La neonata Roland TR-808, infatti, non ebbe un immediato successo commerciale come ci si potrebbe aspettare.
Sul mercato ai tempi era presente un importante concorrente, la Linn LM-1, ovvero la prima drum machine che faceva uso di suoni campionati digitalmente; nonostante il prezzo decisamente più elevato rispetto alla TR-808 (5000 dollari rispetto ai 1200 della Roland), la Linn LM-1 era apprezzata e preferita per la capacità di riprodurre suoni in maniera più realistica.
Ma la TR-808, grazie anche al fatto di essere più accessibile economicamente, riuscirà a creare una sorta di attrazione nel mondo underground che le varrà negli anni a venire lo status di vero e proprio oggetto di culto.» – produzionehiphop.com
Già, paradossi del destino: proprio quella caratteristica ritenuta un difetto – lo “scarso realismo” dei suoi timbri – avrebbe reso la 808 unica e affascinante per una nuova generazione di musicisti sperimentali. Ma nel 1980 ancora non lo sapeva nessuno.
A quel tempo l’industria discografica cercava “batterie vere”, o al limite drum-machine che le imitassero in modo credibile. Tanto che c’è chi sostiene, con il senno di poi, che Roland archiviò presto la TR-808 perché “non suonava come una batteria” e dunque lo considerò un esperimento fallito: del resto, se l’obiettivo dichiarato era emulare una drum-kit reale, il risultato era davvero troppo lontano dalla realtà.
Inutile dire che Kakehashi e soci avevano invece aperto involontariamente la porta su qualcos’altro – una rivoluzione sonora che stava solo aspettando il suo momento per esplodere.
Difetti di fabbrica, suoni futuristici
Cosa rendeva la TR-808 così diversa dalle altre drum-machine? In breve: i suoi transistor difettosi.
Sembra incredibile, ma il segreto di quei suoni tanto particolari stava proprio in alcuni componenti elettronici non conformi alle specifiche standard.
Kakehashi e il suo team, per contenere i costi, acquistarono stock di transistor “fallati” che le aziende produttrici scartavano.
Utilizzandoli nei circuiti audio della 808, ottennero timbri inusuali: snare metalliche, hi-hat fruscianti e, soprattutto, quella cassa che più che un colpo secco era un boom profondo e risonante.
Il kick della 808 è divenuto leggendario: un colpo di basso dall’attacco leggermente “clicky” e la coda lunghissima bassosa, capace di far tremare i woofer.
Un suono elettronico puro, che non cercava di imitare nessun tamburo acustico – semmai lo reinventava in chiave futuristica.
All’epoca, però, questi tratti “sintetici” sembravano un limite. I manuali spiegavano come impostare le regolazioni di tone e decay per avvicinare il suono a quello di un vero tom o di una vera cassa, quasi a scusarsi della sua diversità. Ma col tempo i musicisti capirono che quei presunti difetti erano in realtà porte aperte alla creatività: perché non sfruttare quelle tonalità mai sentite prima per creare sonorità innovative?
Ikutaro Kakehashi stesso, molti anni dopo, rivelò con orgoglio questo retroscena nel documentario “808: The Movie” di Alexander Dunn, quasi a rivendicare che nulla era stato un caso.
Nei titoli di coda del film, il fondatore di Roland – già anziano ma lucidissimo – svela l’arcano di quell’“errore” diventato magia:
«…quel suono inspiegabile e impossibile da riprodurre nella realtà era creato da dei transistor difettosi, che lui aveva utilizzato come generatori di suono.
Un miglioramento della tecnologia rese introvabili i transistor difettosi: “Non ce n’erano più – ammette Kakehashi – quindi niente più 808”.» – repubblica.it
Già, alla fine i transistor “speciali” finirono e con essi anche la 808 cessò di esistere. La Roland lanciò nel 1983 la TR-909 (che combinava suoni analogici e campioni digitali, e avrebbe avuto miglior sorte commerciale), ma ormai il dado era tratto: la TR-808, con i suoi soli tre anni di produzione e le sue sole 12mila unità, stava per diventare un mito. Perfino i suoi limiti tecnici contribuirono alla leggenda. Ad esempio, la 808 non aveva effetti interni: niente riverbero, niente campioni di piatti realistici – solo suoni “secchi”. Ma questo spinse i produttori ad ingegnarsi: chi voleva un suono di rullante più lungo e “splashy” registrava il rullante 808 su un nastro e poi lo rallentava, chi voleva un piatto ride prolungato lo otteneva programmando a mano rapide sequenze di hi-hat. Insomma, la 808 costringeva a essere creativi.
Quei suoni metallici, conturbanti, difficili da ricondurre a qualcosa di reale, all’inizio spiazzavano.
Ascoltare una TR-808 nel 1980 era un’esperienza straniante: “Aspettate, mi state dicendo che ci sono delle percussioni dentro quella macchina?” – ricorda incredulo il batterista Questlove, rievocando il suo primo incontro con l’808. Eppure proprio in quella stranezza risiedeva il potenziale rivoluzionario dello strumento. La 808 non replicava il passato, creava il futuro. Bastava affidarla nelle mani giuste.
Dalle soffitte agli stadio: la rivincita underground
Verso la metà degli anni ’80, mentre la Roland TR-808 usciva di catalogo e veniva liquidata come un passo falso, accadde qualcosa di inaspettato: le scene underground musicali iniziarono ad adottarla con entusiasmo. Complice il fatto che sul mercato dell’usato si cominciavano a trovare le 808 a prezzi stracciati (molti proprietari se ne liberavano per passare alla più recente TR-909 o ad altre macchine), alcuni pionieri del nascente hip hop underground colsero subito le potenzialità di quel suono grosso e alieno.
Il 1982 fu l’anno della svolta. A New York, il DJ Afrika Bambaataa pubblicò “Planet Rock”, un brano destinato a entrare nella storia: fu uno dei primissimi pezzi hip hop ad essere realizzato interamente con strumentazione elettronica – TR-808 inclusa – invece che con basi suonati da band o campionamenti di groove funk.
Il risultato era esplosivo e futuristico: un beat martellante e inedito che fece saltare tutti dalla sedia.
Da quel momento, l’808 divenne il suono distintivo dell’underground rap e della neonata scena electro. Come raccontano le cronache musicali:
«“Planet Rock” è infatti il primo brano di questo genere ad essere suonato interamente con strumentazione elettronica e nel quale si trova un utilizzo massiccio della TR-808.
I nuovi suoni utilizzati, tra i quali uno dei più iconici è sicuramente la “cowbell” tipica della 808, e il mood “futuristico” del pezzo […] ne fanno un successo immediato nell’underground; ad oggi Planet Rock, nonostante sia una traccia hip hop, è considerato come un brano pionieristico dei generi electro, house e trance, soprattutto per il metodo con cui è stato prodotto utilizzando la famosissima drum machine.» – produzionehiphop.com
Bassi pulsanti che battono fortissimo (come ricorda lo stesso Bambaataa nel documentario 808) e suoni mai sentiti prima: l’808 era perfetta per l’underground rap perché era essa stessa fuori dai canoni commerciali.
Un suono nuovo per un genere nuovo. Non a caso “Planet Rock” diventò il manifesto di quella ondata.
Subito dopo Bambaataa, altri ne seguirono: gruppi come i Planet Patrol (Play at Your Own Risk), i Public Enemy (si pensi al rullante di “Yo! Bum Rush the Show”), i Beastie Boys.
Proprio i Beastie Boys, nel loro album di debutto Licensed to Ill (1986) prodotto da Rick Rubin, sfruttarono la TR-808 al massimo – persino facendo suonare una cassa 808 al contrario nella traccia “Paul Revere”, per ottenere un effetto straniante e innovativo.
Nel giro di pochi anni, quella che era nata come una semplice drum-machine per demo si era trasformata nell’ingrediente segreto di una rivoluzione musicale.
Dall’hip hop alla nascente house di Chicago, dalla techno di Detroit fino al pop: la 808 filtrò ovunque.
Un caso emblematico fu “Sexual Healing” di Marvin Gaye (1982): un brano R&B lento e sensuale, aperto dal groove inconfondibile di una TR-808 che fa tum-cha, tum-cha (cassa, clap, rullante, charleston aperto).
Chi l’avrebbe mai detto? Un’icona del soul che abbraccia una drum-machine elettronica al posto del batterista in carne e ossa!
Il pubblico amò quel suono: la canzone divenne una hit mondiale, dimostrando che l’808 poteva funzionare anche fuori dall’underground.
Da lì in avanti, la lista di successi con l’808 è interminabile. Negli anni ’80 la si sente in brani di Whitney Houston (“I Wanna Dance With Somebody” ha la batteria elettronica 808 in levare), dei produttori di Minneapolis come Jimmy Jam & Terry Lewis, di gruppi electro-funk come la SOS Band, e così via.
Negli anni ’80 la TR-808 era diventata la regina del ritmo: portatile, intuitiva, immediata – uno strumento che permetteva a chiunque di sperimentare e creare beat inediti premendo pochi “bottoni magici”.
Il sound 808 oggi: dalla trap al mito
A più di quarant’anni di distanza, l’eco dell’808 risuona ancora fortissima. Nel linguaggio della produzione musicale contemporanea, “808” è sinonimo di basso: quando nei brani trap si parla di “808”, ci si riferisce a quelle note basse lunghe e potenti (derivate dalla cassa della TR-808) che fanno vibrare l’aria e i woofer.
È curioso come un termine tecnico sia diventato uno slang: l’808 non è più solo la macchina in sé, ma il suono profondo che essa produce. Per chi non frequenta l’ambiente può creare confusione – “808” originariamente indicava l’intera drum-machine, e negli anni ’80 significava semplicemente la grancassa della 808, non un sub-bass. Ma oggi tutti sanno che se un producer ti dice “metti un 808 qui”, ti sta chiedendo di aggiungere quella botta di basso rotonda e vibrante. Possiamo riassumere così questa evoluzione:
«Mentre il termine originale “808” era usato per descrivere la macchina TR-808 nel suo complesso, il termine è ora usato per descrivere il suono del basso […] Sebbene sia ancora possibile utilizzare il termine 808 per descrivere hi-hat, rullanti o tom della macchina originale, si può quasi sempre presumere che qualcuno stia parlando del suono di basso quando dice 808.» – emastered.com
In pratica, il significato di “808” nella trap (e nella musica odierna) è proprio questo: un tipo di basso sintetico, derivato dalla cassa 808, che viene spesso usato come linea di basso melodica oltre che ritmica.
Per fare un esempio noto, il rapper Kanye West intitolò nel 2008 un intero album “808s & Heartbreak” proprio in omaggio a quel suono di basso 808 che pervadeva le sue nuove produzioni.
Un altro esempio iconico? “Bad Boy for Life” di Puff Daddy (2001), prodotta da Megahertz. Il beat pesante e incisivo è costruito su una cassa 808 distorta che dà al brano una marcia minacciosa e inarrestabile. Un caso emblematico di come la TR-808, ormai entrata nella produzione professionale hip hop, venga usata non solo per il groove, ma per definire attitudine e presenza sonora.
Da allora, la presenza dell’808 nel pop e nel rap non ha fatto che crescere: pensiamo alle produzioni di Drake, di Lil Wayne, di artisti trap come Gucci Mane o Migos – tutti innamorati di quelle sub-bass da far tremare i vetri.
Ma non è solo questione di trap. L’808 è celebrata a 360 gradi: esistono documentari a lei dedicati (“808” di Alexander Dunn, con testimonianze di star come Pharrell Williams, Fatboy Slim, Phil Collins, quest’ultimo grande utilizzatore della 909), gruppi che ne portano il nome (i britannici 808 State), e in generale un riconoscimento unanime del suo status di leggenda.
Cosa significa “808” nella musica? Significa innovazione, significa il punto in cui la musica elettronica ha preso un pezzo di rivoluzione e l’ha messa nelle mani di tutti.
Oggi non serve più scovare un’unità hardware vintage per godere di quei suoni: esistono tanti software che riproducono i suoni originali dell’808, dai plug-in ufficiali Roland alle innumerovoli emulazioni freeware e app mobili. Insomma, quell’essenza è diventata parte del linguaggio musicale universale.
Roland 808303.studio – emulatore online gratuito – Sito ufficiale Roland per il 50º anniversario, riproduce in browser una TR-808 + TB-303 Roland50 Studio
iO-808 – TR-808 web app gratuita – Un fedele clone della TR-808 interamente in browser, per creare beat e salvarli io808.com
Roland TR-808 Cloud (plugin ufficiale) – Versione virtuale autorizzata Roland della TR-808, con tecnologia Analog Circuit Behavior (richiede abbonamento Roland Cloud) – Roland Cloud TR-808
D16 Nepheton 2 (plugin VST) – Emulazione professionale della TR-808 con funzioni estese ed effetti integrati (versione demo disponibile) – D16 Nepheton2
I 10 album fondamentali da avere in vinile con la Roland TR-808
Ascoltare la Roland TR-808 in digitale va bene. Ma su vinile è tutta un’altra storia. Quei bassi profondi, quelle rullate secche e quelle cowbell spaziali acquistano un calore e una presenza che solo il solco può restituire.
Voi goderti davvero la TR-808 come si deve, e magari anche fare bella figura con gli amici audiofili? Ecco 10 album fondamentali da avere in vinile: dischi in cui la drum-machine di casa Roland non solo compare, ma è protagonista assoluta, ispirando groove, testi, sperimentazioni.
Ecco la playlist da vinile definitiva per gli amanti della 808:
- Afrika Bambaataa & The Soulsonic Force – Planet Rock (1982)
Il manifesto sonoro della 808. Il primo brano electro-hip hop a usare massicciamente la TR-808. Un capolavoro futurista. - Marvin Gaye – Midnight Love (1982)
Include “Sexual Healing”, una delle più sensuali ballad elettroniche mai incise. Sì, quel beat morbido è tutta opera della 808. - Whitney Houston – Whitney (1987)
Hit come “I Wanna Dance with Somebody” usano la TR-808 per far ballare anche le tende. L’anima pop della drum-machine. - Beastie Boys – Licensed to Ill (1986)
La 808 al servizio del rap bianco più irriverente. Ascoltate “Paul Revere” per un uso creativo al contrario della cassa. - Run-D.M.C. – Run-D.M.C. (1984)
Un classico del rap old-school. Il suono è crudo, diretto, martellante. La TR-808 fa il suo dovere, senza tanti effetti. - Cybotron – Enter (1983)
Primo progetto techno di Juan Atkins. Un album visionario dove l’808 detta legge nei territori dell’electro-futurismo. - LL Cool J – Radio (1985)
Prodotto da Rick Rubin, l’album mostra la TR-808 in versione “bad boy”. Secca, potente, spartana. Hip hop puro. - Kraftwerk – Electric Café (1986)
I pionieri del suono sintetico non potevano ignorare la 808. L’album è un laboratorio di suoni, tra cui spiccano le drum-machine Roland. - 808 State – Ninety (1989)
La 808 nel nome e nei suoni. Album techno britannico d’avanguardia che consacra la drum-machine nei club di tutto il mondo. - Kanye West – 808s & Heartbreak (2008)
Non vintage, ma imprescindibile. Qui la 808 diventa un simbolo emotivo, profondo. Il disco che ha reintrodotto la drum-machine nell’immaginario pop del nuovo millennio.
Rap vs Hip hop: cugini stretti ma non identici
Parlando di 808 e di trap, ci siamo addentrati profondamente nel territorio dell’hip hop. Ma a questo punto vale la pena chiarire un dubbio che spesso sorge ai neofiti: qual è la differenza tra il rap e l’hip hop? I due termini vengono a volte confusi o usati come sinonimi, ma indicano concetti diversi (anche se strettamente legati). Cerchiamo di spiegarlo in modo semplice.
Hip hop è un termine ombrello che si riferisce a un’intera cultura nata negli anni ’70 nei ghetti di New York: comprende musica, certo, ma anche arte di strada (graffiti), ballo (breakdance), moda, slang, e uno specifico stile di vita.
In particolare, tradizionalmente si dice che l’hip hop si fondi su quattro elementi principali:
- il DJing (ovvero l’arte del dj/producer nel creare basi e tagliare i dischi);
- l’MCing ossia il rap (il canto parlato ritmato);
- il breaking (la danza breakdance);
- il writing (i graffiti).
Il rap è una parte dell’hip hop – precisamente la parte musicale vocale. Quando diciamo “musica hip hop”, in pratica intendiamo “musica rap”, perché la componente sonora principale della cultura hip hop è fatta di rapper che cantano su basi prodotte da DJ o beatmaker. Ma l’hip hop come fenomeno va oltre la musica: è, per citare qualcuno, una cultura che impatta su tutti gli aspetti della vita.
Il rap è tecnicamente lo stile canoro (o parlato) che caratterizza la musica hip hop. È quell’azione di “rappare”: inventare e recitare rime a ritmo su un beat.
Il rap può esistere anche fuori dal contesto strettamente hip hop – ad esempio lo si può fare su una base rock, o su un pezzo elettronico – ma storicamente nasce dentro l’hip hop e ne è l’espressione più riconoscibile.
Qualcuno l’ha spiegato con una metafora efficace: l’hip hop è l’albero, il rap è uno dei suoi rami. Oppure, come disse il leggendario KRS-One, “il rap è qualcosa che fai, l’hip hop è qualcosa che vivi”. Significa che l’hip hop è uno stile musicale ma anche un modo di essere, mentre il rap è la tecnica vocale, l’atto pratico di fare musica hip hop.
In sintesi: rap è la parte musicale (il “canto” ritmato), hip hop è il genere e la cultura nel suo complesso.
Un artista può essere definito “rapper” per come performa, mentre “artista hip hop” ha un’accezione più ampia che include l’appartenenza a tutto un movimento.
Anche in italiano spesso si usa “rap” per riferirsi alla musica e “hip hop” alla cultura; altre volte si parla di “musica hip hop” intendendo comunque la musica rap.
L’importante è capire il concetto: tutti i rapper fanno parte della cultura hip hop, ma non tutta la cultura hip hop si esaurisce nel rap.
L’underground rap (o undie): fuori dai canoni commerciali
Un altro termine che abbiamo incontrato è hip hop underground (o rap underground). Ma cosa vuol dire rap underground?
Qui entriamo in ambito di classificazioni qualitative più che tecniche. In generale, si definisce “underground” quell’hip hop che si sviluppa a distanza dai canoni commerciali, fuori dai riflettori delle grandi etichette e delle mode radiofoniche del momento. È un modo per indicare tutta la scena indipendente, alternativa, spesso autoprodotta, dell’hip hop.
Non parliamo quindi di un sottogenere musicale preciso (perché a livello di sonorità l’underground rap può essere il più vario possibile), ma di una categoria di musica hip hop che si colloca deliberatamente lontano dal mainstream e dalle logiche di mercato di massa.
Gli americani lo chiamano anche indie hip hop o scherzosamente “undie”. Gli artisti underground spesso pubblicano per etichette indipendenti o addirittura su etichette proprie, stampandosi i dischi da soli, vendendoli magari ai concerti o tramite passaparola.
Il pubblico è quello dei circoli underground, delle community di appassionati che seguono il genere per amore e non perché spinto dalle hit del momento.
Il bello dell’underground rap è la libertà creativa: i testi possono essere più crudi, sperimentali, politicamente impegnati o semplicemente strani, senza cercare a tutti i costi il ritornello orecchiabile o il tormentone da classifica. Anche le basi possono avere sonorità innovative, attingendo al jazz, al funk, al soul, senza preoccuparsi di suonare radio-friendly.
Proprio per questo, molti considerano l’underground come il luogo dove l’hip hop mantiene la sua autenticità originaria.
Possiamo rifarci a una definizione enciclopedica per riassumere il concetto:
«L’underground hip hop, detto anche underground rap o undie (talvolta indie hip hop o indie rap), è un termine generico che raccoglie tutti gli artisti hip hop fuori dai classici canoni commerciali.
Le etichette hip hop indipendenti sono le principali fonti di supporto per gli artisti di questo genere ma molta parte è rappresentata da coloro che realizzano il proprio materiale grazie ad autoproduzioni o tramite proprie micro-etichette personali.
Questo hip hop non commercializzato è spesso composto da artisti che alternano la musica ad altri elementi della cultura hip hop come il writing, il breaking, il freestyle ed il beatboxing.»i – t.wikipedia.org
In altre parole, l’underground è la “scena alternativa” dell’hip hop. Un esempio storico: negli anni ’90, mentre il gangsta rap di Dr. Dre e Snoop Dogg dominava le classifiche, c’era un sottobosco di artisti come Mos Def, Talib Kweli, Company Flow, MF DOOM (solo per citarne alcuni) che pubblicavano per piccole etichette e pur avendo un seguito di culto non passavano in radio.
Quella era la scena underground di allora. Oggi i confini sono un po’ cambiati (con Internet molti artisti nascono indipendenti e poi magari esplodono nel mainstream), ma il termine rap underground si usa ancora per indicare il rap più di nicchia, l’underground rap appunto, contrapposto al rap commerciale da classifica.
Va detto che underground non significa per forza migliore o peggiore – è più che altro una distinzione di contesto.
Ci sono album underground considerati capolavori assoluti dell’hip hop, così come scene underground piene di sperimentazioni interessanti.
In ogni caso, se sentite parlare di “undie”, ora sapete che si riferisce affettuosamente a quel mondo sotterraneo del rap indipendente.
Quanti tipi di hip hop ci sono?
Difficile contarli! L’hip hop si è diramato in tantissimi sottogeneri: dall’east coast al west coast, dal southern hip hop (che include la trap di Atlanta) al boom bap newyorkese, dal gangsta rap al conscious rap, passando per vari incroci con altri generi (jazz rap, rap-rock, ecc.).
Ogni scena locale spesso sviluppa un suo stile. Ma tutti condividono le radici comuni dell’hip hop e l’eredità di quel suono originale – nel quale, guarda caso, la TR-808 ha avuto un ruolo fondamentale.
The Drum In The Machine
Siamo partiti da una semplice drum-machine e siamo arrivati a parlare di cultura e sottoculture: niente male per una “scatoletta ritmica” nata quasi per caso!
La Roland TR-808 si è guadagnata il titolo di macchina che inventò l’hip-hop non perché da sola abbia creato un movimento (dietro c’erano persone, comunità, fermenti sociali), ma perché è diventata lo strumento emblematico che ha dato voce e ritmo a quel movimento.
Il suo suono della Roland TR-808 ha definito un’era e continua ancora oggi a far muovere teste e piedi in tutto il mondo.
A proposito di mondo: chi ha portato l’hip hop in Italia? La cultura hip hop sbarcò nel nostro Paese nei primi anni ’80 grazie ad alcune figure pionieristiche e all’importazione dei primi spettacoli.
In particolare, fu Afrika Bambaataa – sì, proprio lui, l’autore di Planet Rock – a introdurre ufficialmente l’hip hop in Italia con il suo primo tour mondiale nel 1983. Inoltre, l’arrivo di film come Wild Style e Beat Street (trasmessi sulle TV private locali) ispirò tanti giovani italiani ad abbracciare breakdance, graffiti e rap.
Da lì germogliò la scena italiana, che nei decenni successivi avrebbe avuto i suoi eroi (dai Radical Stuff a Jovanotti – precursore mainstream – fino alla golden age anni ’90 con Articolo 31, Neffa, Frankie hi-nrg e oltre).
Oggi l’eredità dell’808 e dell’hip hop continua in mille forme: c’è chi programma beat su laptop seduto al tavolo di cucina, c’è chi studia nei testi universitari l’impatto sociale di questa cultura e c’è chi semplicemente alza il volume quando parte una cassa 808 perché non può resistere a quel groove.
Ikutaro Kakehashi, scomparso nel 2017, probabilmente sorriderebbe sapendo che quell’errore di fabbricazione – quei transistor “bizzarri” – hanno lasciato un’impronta indelebile. Come ha detto David Guetta, “è incredibile pensare a come una macchina così piccola abbia lasciato una tale impronta nel mondo della musica”. Già: incredibile ma vero. Quel che è nato quasi per scherzo – un ppsss di tè rovesciato su un circuito, un kick che suona come un tuono sintetico – è diventato la base su cui poggia un intero universo sonoro.
Insomma, lunga vita all’808 e a ciò che rappresenta. La magia dell’808 è democratica: ieri come oggi fa ballare il mondo al mistico suono di quei boom boom clap che continuano a fare scuola.