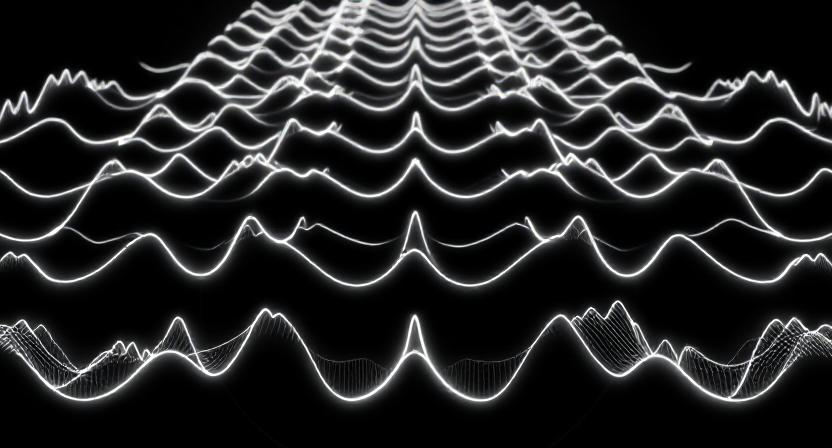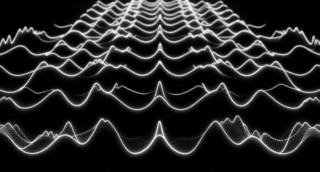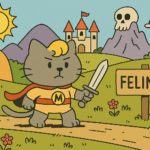C’era una volta la Londra anarchica, impastata di malcontento, energia tossica e creatività allo stato grezzo.
Una Londra post-Sex Pistols, dove la borghesia stringeva i denti e i giovani si tingevano i capelli di nero per dichiarare guerra all’apatia.
In mezzo a questo magma punk sbocciò qualcosa di profondamente diverso, una creatura oscura, seducente e inafferrabile: Siouxsie and the Banshees. Non era solo una band. Era una specie di koan zen, lanciato nel bel mezzo di una scena musicale ancora confusa su cosa significasse davvero essere “alternativi”.
Poi c’era lei: Siouxsie Siou, con quegli occhi bistrati che sembravano bucare lo schermo della TV, regina di un regno gotico prima ancora che il gotico fosse una moda.
La loro discografia, che attraversa gli anni 80 come un coltello affilato, è uno specchio riflesso buttato nel cesso: quello che resta è pura essenza.
Un viaggio che parte dalle macerie del punk e approda in territori dark-punk, sperimentali, pop decadente e atmosfere da incubo.
Un corpus che conta 11 album in studio, di cui ben 7 pubblicati negli anni Ottanta, l’epoca d’oro della band.
Sì, anche Robert Smith dei Cure ha suonato con loro. E no, non sono solo una band goth. Sono molto di più, come scoprirai nelle prossime pagine.
Kaleidoscope (1980, Polydor Records)
“You don’t know me but you know me well / You don’t own me but you know me well.” — da “Happy House”
Con Kaleidoscope, i Banshees mettono definitivamente in chiaro di non essere semplicemente un’emanazione del punk.
L’uscita di John McKay e Kenny Morris, che seguì a tensioni interne e a un celebre abbandono prima di un concerto, segnò un punto di svolta.
Al loro posto arrivarono Budgie, già con The Slits, e John McGeoch, chitarrista visionario ex Magazine: il suono cambia, si arricchisce, si complica.
“Happy House” è l’inno ironico per una società che finge serenità dietro pareti di plastica, un pezzo dalle sonorità quasi reggae che contrasta volutamente con la claustrofobia del testo.
“Christine” racconta con inquietante delicatezza la sindrome della personalità multipla, ispirandosi alla vera storia di Christine Sizemore. Il brano gioca con le strutture ritmiche e melodiche come uno specchio deformante.
Kaleidoscope è il disco della trasformazione, del nuovo inizio, una reinvenzione estetica e sonora che trasforma il caos post-punk in qualcosa di più sottile e sinistro. Londra non è più solo anarchica: è surreale, elettrica, ipnotica.
Juju (1981, Polydor Records)
“Following the footsteps of a rag doll dance / We are entranced — Spellbound.” — da “Spellbound”
Forse il loro capolavoro. Juju è un rito tribale in chiave post-punk, un disco ossessivo, secco, spigoloso, costruito con una precisione quasi maniacale e un’intensità che non dà tregua.
Si tratta di un album dominato dall’occulto, dalla paranoia, dalla tensione psicologica che serpeggia in ogni traccia come una corrente elettrica sotto pelle.
La chitarra di McGeoch è un vortice di arpeggi metallici e grida controllate, una tessitura sonora che avvolge l’ascoltatore in un incantesimo ipnotico.
Budgie, dal canto suo, costruisce pattern ritmici che sembrano incantamenti tribali, rituali ancestrali modernizzati dal fuoco dell’elettricità.
“Spellbound” è un singolo magistrale, con una linea di chitarra ossessiva e circolare che trasforma l’ascolto in una danza stregata, mentre “Arabian Knights” fonde atmosfere orientaleggianti e liriche al vetriolo contro l’ipocrisia occidentale. Altrove, brani come “Into the Light” e “Monitor” esplorano territori sonori inediti, tra distorsioni e reverberi, mantenendo una coerenza narrativa e stilistica che rende l’album compatto e impenetrabile.
Juju è dove il dark-punk trova la sua forma più pura e sublime. È anche l’album dove la gente ci restava di sasso.
Non era solo musica: era un’esperienza estetica totalizzante, un rituale sonoro che ancora oggi conserva il potere di evocare mondi interiori inesplorati.
A Kiss in the Dreamhouse (1982, Polydor Records)
“We blend into the background / Like a dream in monochrome, we fade away…” — da “Melt!”
Un disco lisergico, sensuale, barocco. A Kiss in the Dreamhouse segna uno dei momenti più audaci della carriera dei Banshees, in cui l’art rock viene abbracciato con una teatralità visionaria che sovverte del tutto le radici punk da cui erano partiti.
Gli arrangiamenti, ricchi di archi, fiati e sovraincisioni vocali, trasformano ogni canzone in un piccolo labirinto psichedelico.
L’intero album è immerso in una qualità onirica, come un sogno a occhi aperti dentro un teatrino liberty sfigurato.
“Slowdive” apre il disco come un’onda sensoriale, un valzer inebriante tra eros e disfacimento.
La voce di Siouxsie Siou si fa quasi liquida, galleggia su tappeti orchestrali che non temono l’eccesso.
Altri brani come “Melt!” e “Obsession” sono veri e propri drammi in miniatura, sospesi tra desiderio e claustrofobia, tra seduzione e allucinazione.
L’intero album sembra trasportare l’ascoltatore in un bordello decadente di inizio secolo, ma riprodotto con i colori acidi e sghembi di un sogno anni ’80.
È come se avessero trovato una nuova formula magica davvero misteriosa e l’avessero sparsa su tutto: un incantesimo di velluto e vetro spezzato che ancora oggi risuona con potenza.
Nocturne (1983, Polydor Records – live)
“Cascade your lashes like summer rain / Through shadows and lights, you still remain…” — da “Night Shift”
Registrato dal vivo al Royal Albert Hall con Robert Smith alla chitarra, Nocturne non è solo un disco live: è un documento storico, un frammento sonoro che cattura la tensione elettrica e l’eleganza oscura di una band al culmine della sua potenza.
La setlist, che include brani da Juju, Kaleidoscope e A Kiss in the Dreamhouse, è un viaggio tra incubi lucidi e visioni psichedeliche.
La performance di Siouxsie è magnetica, ieratica, capace di passare dall’ipnosi vocale al grido selvaggio con una naturalezza disarmante. Robert Smith, temporaneo ma essenziale, si muove come un fantasma discreto tra i riff, aggiungendo strati di chitarra liquida e tagliente che danno nuova vita ai brani.
La versione live di “Night Shift” è un crescendo sinistro che sembra materializzare la violenza repressa sotto il palco, mentre “Voodoo Dolly” chiude come una seduta spiritica degenerata in trance collettiva.
Con Nocturne, i Banshees dimostrano che anche dal vivo riescono a evocare un’atmosfera glaciale e ipnotica, trasformando il concerto in un’esperienza rituale, oscura e profondamente teatrale.
Hyaena (1984, Polydor Records)
“We fall to rise / To climb from the wreckage of dreams” — da “Dazzle”
Primo (e unico) album in studio con Robert Smith come membro ufficiale. Hyaena è un disco pieno di contrasti: melodie eteree e dissonanze improvvise, bellezza e inquietudine, luce e abisso.
I Banshees non hanno mai avuto paura di flirtare con l’eccesso, ma qui si spingono ai limiti dell’isteria orchestrale.
“Dazzle” apre il disco con un’esplosione di archi, realizzati in collaborazione con il compositore Martin McCarrick, evocando atmosfere da tragedia classica in technicolor: una sorta di ouverture sinfonica trasfigurata nel linguaggio post-punk. Il brano si muove con un senso di maestosità tragica, come se il cielo stesso stesse per crollare sul mondo. Dietro la teatralità, pulsa un cuore emotivo sincero.
Brani come “We Hunger” e “Belladonna” si muovono tra il gotico e l’etereo, alternando spigolosità new wave a momenti di quasi trasparente malinconia.
Smith, con il suo stile sognante e melodico, porta una sensibilità più romantica e stratificata nel sound della band, arricchendolo senza snaturarlo.
“Swimming Horses” tocca il tema della violenza familiare con una delicatezza lirica mai predicatrice, mentre “Running Town” è una miniatura surreale che sembra uscita da un sogno infranto.
Un album instabile, strano, eppure magnetico, Hyaena è il punto in cui la ferocia dei Banshees si fa sofisticata, e la loro estetica gotica assume tratti barocchi e persino commoventi.
Tinderbox (1986, Polydor Records)
“This is the happy house / We’re happy here in the happy house / To forget ourselves and pretend to be free…” — da “Cities in Dust”
Dopo l’uscita di Smith, il gruppo si ricompatta con John Valentine Carruthers alla chitarra. Tinderbox è un ritorno alla forma, ma anche una raffinazione del caos visionario degli anni precedenti.
La produzione è più pulita, quasi epica, ma senza perdere l’asprezza che definisce il suono dei Banshees.
“Cities in Dust”, il brano più celebre, racconta la caduta di Pompei con immagini forti, come se fosse l’epilogo di un amore fallito sotto nuvole di cenere. Il resto dell’album non è da meno.
“Cannons” è un esercizio di tensione sospesa, mentre “92°” trasforma la paranoia in groove meccanico.
“This Unrest” sembra uno sfogo lirico tra disagio esistenziale e sogno disfunzionale. L’elettronica si insinua in modo sottile, tra synth appena accennati e riverberi dilatati, rendendo l’atmosfera più moderna ma ancora visceralmente bansheeana.
Budgie, sempre più centrale, guida il suono con una batteria precisa e tribale, mentre Siouxsie canta con una consapevolezza nuova, più matura, più enigmatica.
Through the Looking Glass (1987, Polydor Records)
“Strange fruit hanging from the poplar trees / Blood on the leaves and blood at the root / Black bodies swinging in the southern breeze…” — da “Strange Fruit”
Un album di cover che è molto più di un semplice esercizio di stile: Through the Looking Glass è un laboratorio estetico in cui Siouxsie and the Banshees si confrontano con i fantasmi del passato per rimodellarli a loro immagine e somiglianza.
Ogni brano viene spogliato e rivestito di una nuova pelle, a volte in lattice, a volte in velluto, sempre intrisa di inquietudine.
I Banshees reinterpretano Billie Holiday, Sparks, Bob Dylan, Iggy Pop e altri come se fossero reliquie di un tempio decadente.
“This Wheel’s On Fire” è una marcia allucinata, lenta e minacciosa, che perde la sua origine folk e assume i contorni di una discesa negli inferi.
“Strange Fruit” è un requiem industriale, spoglio e crudele, che amplifica la tensione già insopportabile del testo originario, trasformando la denuncia in un urlo trattenuto.
“Hall of Mirrors” dei Kraftwerk viene decostruita fino a diventare una visione opaca e sinistra dell’identità.
È un album specchio: riflette il mondo esterno ma lo deforma, lo rende banshees-style. Ogni canzone è come un volto riplasmato nella cera, familiare ma inquietante, e forse proprio per questo irresistibile.
Peepshow (1988, Polydor Records)
“Peek-a-boo, peek-a-boo, little girl / You’re everywhere and nowhere at once / Through a keyhole we spy” — da “Peek-a-Boo”
Il pop più sperimentale mai prodotto dalla band. Con Martin McCarrick e Jon Klein, Peepshow è un circo gotico, una lanterna magica dove ogni traccia rappresenta una nuova stanza di meraviglie e orrori.
È un album che si diverte a confondere le coordinate dell’ascoltatore, facendo convivere l’estetica del vaudeville con quella del post-industrial più sofisticato.
“Peek-a-Boo” è un singolo dirompente, che alterna fisarmoniche mediorientali a beat spezzati, come una parata deformata uscita da un sogno disturbante. Ma è solo la punta dell’iceberg.
“Scarecrow” evoca paesaggi desolati tra psichedelia e marcette circensi, mentre “Carousel” suona come una nenia da incubo, un carillon rotto che continua a girare nell’oscurità.
La voce di Siouxsie è più teatrale che mai, capace di trasformarsi da sussurro infantile a comando imperioso, da ironia tagliente a pathos puro.
L’album mantiene intatta l’attitudine punk, ma la declina in modo radicalmente postmoderno, giocando con i generi, le atmosfere e le aspettative.
Peepshow non è solo un disco: è uno spettacolo disturbante in cui lo spettatore si ritrova improvvisamente sul palco, sotto i riflettori.
Dopo gli anni Ottanta: tra ombre e tramonti
Negli anni Novanta, i Banshees pubblicano Superstition (1991, Polydor Records) e The Rapture (1995, Polydor Records), due lavori che riflettono la tensione tra il desiderio di evoluzione e la fedeltà a un’estetica ormai consolidata.
Il primo, prodotto da Stephen Hague (già al lavoro con Pet Shop Boys e New Order), contiene la hit “Kiss Them for Me”, brano che fonde l’eleganza synth-pop con una vena orientaleggiante, dedicato all’attrice Jayne Mansfield.
Il suono si fa più levigato, elettronico, e l’oscurità assume toni glamour e seducenti. Anche pezzi come “Fear (of the Unknown)” mostrano un lato più danzereccio e accessibile della band, senza tuttavia perdere del tutto il carattere introspettivo e misterioso.
Con The Rapture Siouxsie and the Banshees tentano un’opera più ampia e stratificata. L’album si apre con “O Baby”, quasi un brano pop retrò, ma si inoltra presto in territori più densi e cupi: la title track è una suite lunga e ambiziosa che alterna momenti orchestrali a improvvise rarefazioni.
“Fall from Grace” e “Not Forgotten” riprendono le atmosfere più gotiche dei lavori precedenti, ma attraverso una lente più malinconica, quasi testamentaria.
Il disco è diviso tra leggerezza e peso, tra desiderio di rinascita e consapevolezza della fine.
Il tempo, però, inizia a mostrare la sua ombra. Gli anni Novanta sono meno indulgenti verso chi viene dal decennio precedente.
Il britpop imperversa, la scena cambia, e i Banshees sembrano figure di un’altra epoca. Eppure anche qui c’era qualcosa: una ricerca di bellezza nell’apocalisse, una nostalgia che si fa suono. Un addio che non sembrava definitivo, che porta con sé un misto di estasi e smarrimento.
Discografia completa
Anni 80:
- Kaleidoscope (1980, Polydor Records)
- Juju (1981, Polydor Records)
- A Kiss in the Dreamhouse (1982, Polydor Records)
- Nocturne (1983, Polydor Records – live)
- Hyaena (1984, Polydor Records)
- Tinderbox (1986, Polydor Records)
- Through the Looking Glass (1987, Polydor Records)
- Peepshow (1988, Polydor Records)
Dopo gli anni 80:
- Superstition (1991, Polydor Records)
- The Rapture (1995, Polydor Records)
Porta socchiusa su una stanza scura

Siouxsie and the Banshees non sono semplicemente una band goth, né solo una reliquia degli anni 80. Sono un’idea. Un punto interrogativo truccato di nero. Un’eco di Londra anarchica che ancora oggi risuona nei corridoi più bui della musica alternativa.
Hanno saputo trasformare il disagio in bellezza, l’alienazione in estetica, il punk in arte. Ogni loro album è una porta socchiusa su un mondo che non esiste più, ma che aspetta ancora di essere riscoperto. Perché, alla fine, come diceva Siouxsie Siou in una vecchia intervista: “Non ci interessava adattarci. Ci interessava creare un nuovo universo”.