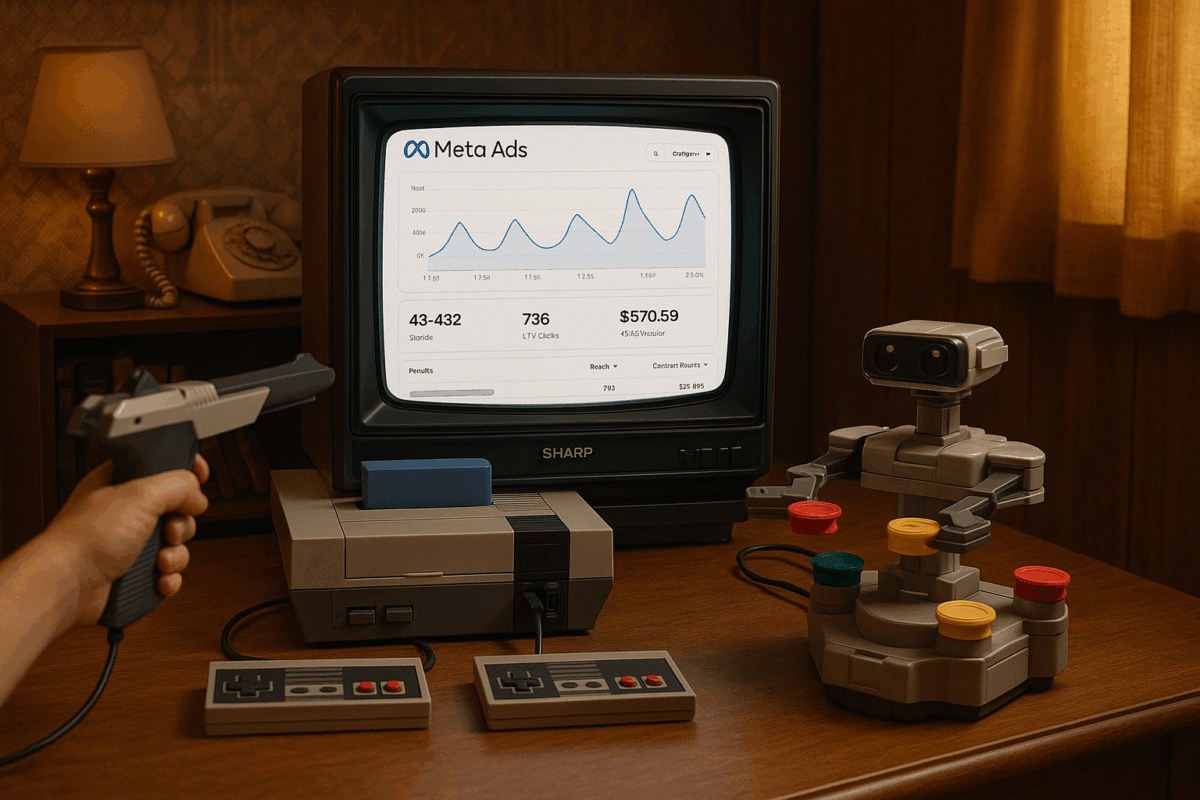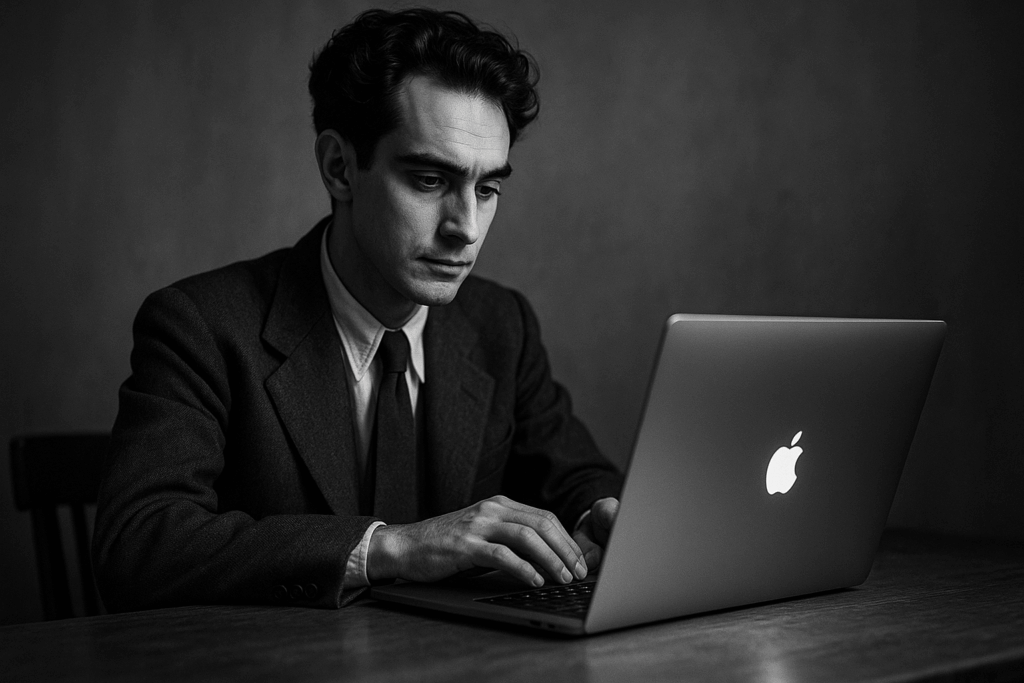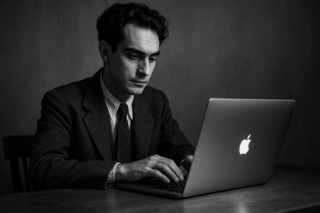Nel 1984 – non il romanzo, ma l’anno solare – la pubblicità si misurava ancora in battute, jingle ripetuti all’infinito e poster affissi sulle fermate degli autobus, che lentamente sbiadivano sotto il sole estivo.
L’Italia era una repubblica fondata sul Carosello, la réclame una liturgia familiare e le mamme credevano che lo Zingaro con il baffo del dado cucinasse davvero meglio di loro.
La pubblicità era umana, fin troppo. Troppo seduttiva, certo. Troppo mitologica. Ma pur sempre umana. Era il nostro Super Mario culturale: semplice, colorato, familiare. Una narrazione condivisa che ci diceva dove saltare, cosa evitare, quando fermarci.
E ora?
Secondo Mark Zuckerberg – profeta della Silicon Valley, noto per aver trasformato il tempo libero dell’umanità in un flusso monetizzabile – arriveremo presto “al punto in cui un’azienda collegherà il proprio conto bancario e dichiarerà un obiettivo. Stop. L’intelligenza artificiale farà tutto da sola: creerà varianti di annunci, le testerà, le ottimizzerà”.
Senza creatività. Senza target. Senza umani. Senza mani. Ne joystick.
La trappola infinita della tautologia algoritmica
La dichiarazione di Mark ha il tono ieratico della profezia, ma anche l’odore stantio delle tautologie che si mordono la coda. Se è vero che l’AI può produrre contenuti infiniti, ricordiamo allora Borges: un’enciclopedia infinita non è utile, è paralizzante.
La macchina è perfetta nella sua ottusità. Può generare miliardi di varianti. Ma non proverà mai alcun tipo di empatia di fronte al gattino di uno spot pubblicitario. Per lei, sarà soltanto un pixel color seppia. Non capirà mai che “Dove c’è Barilla, c’è casa” non era uno slogan, ma un archetipo junghiano.
Da mito a metadato
Cosa c’era nelle pubblicità degli anni ’80 che oggi rischiamo di perdere? Un certo grado di mitologema.
Il padre che tornava a casa col pane. Il bambino che scartava la merenda. L’anziano saggio dallo sguardo dolce. Erano solo segni, certo. Ma erano segni caldi, secondo la definizione di McLuhan.
Oggi il messaggio si raffredda, si svuota, si automatizza. L’advertising – da arte simbolica – diventa tecnocronaca, algoritmi che misurano click senza cogliere l’epifania del desiderio.
Ricordate quando l’algoritmo pubblicitario di Amazon suggeriva corde e sgabelli agli utenti depressi? Ecco cosa succede quando affidiamo l’intimità umana a un algoritmo.
Apocalisse / Integrazione
Come negli anni ‘60, siamo nuovamente davanti a un bivio: da un lato gli apocalittici, che vedono nell’AI pubblicitaria la fine della creatività umana; dall’altro gli integrati, che vi scorgono una liberazione dalla tirannia del genio.
Entrambi dimenticano che l’intelligenza artificiale non potrà mai essere realmente intelligente se non sarà anche ironica, ambigua, fallibile.
Perché l’ironia – come disse Paul Virilio – è l’ultima difesa dell’uomo contro le macchine. È ciò che ci permette di vedere i limiti dell’algoritmo, è quel sorriso segreto che sfugge alla programmazione.
Game Over?
Forse è bene ricordare che la pubblicità non è mai stata solo uno strumento di vendita. È sempre stato un linguaggio dell’inconscio collettivo. Come ogni linguaggio, sopravvive solo inventando nuovi codici senza perdere i vecchi significati.
Nel 1984 bastava un regista di talento. Oggi serve un’anima. Forse anche una vita extra. Come nei vecchi giochi Nintendo, dove ogni errore non significava la fine, ma un “Retry”. Solo che oggi, se lasciamo il controller all’algoritmo, potremmo non avere più modo di tornare al menu principale.
Apocalittici, integrati o semplici personaggi non giocanti? A noi la scelta.