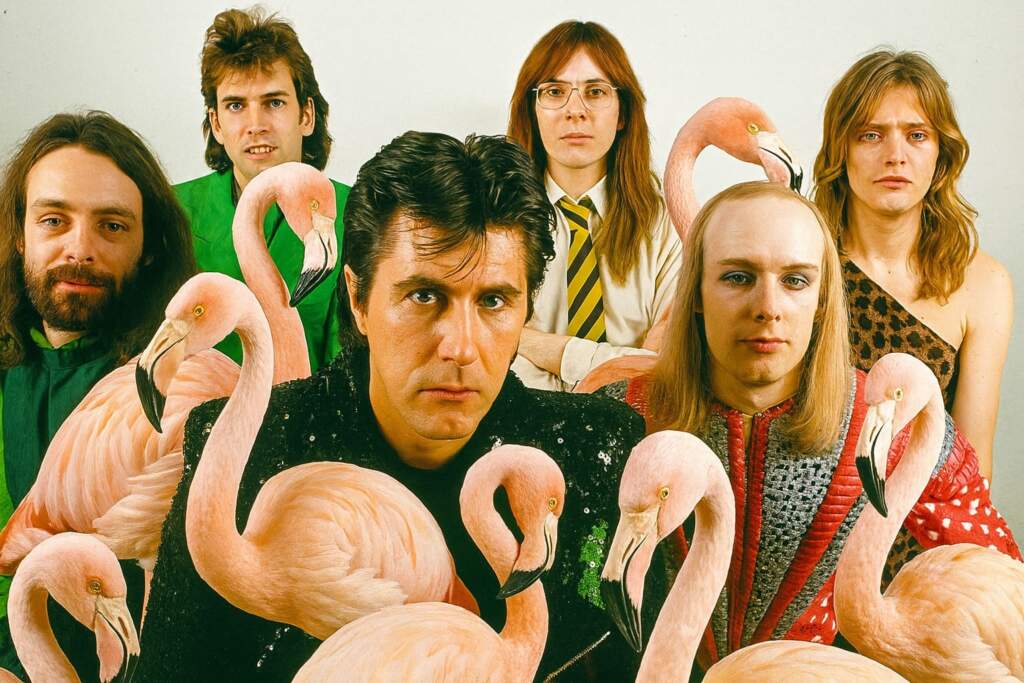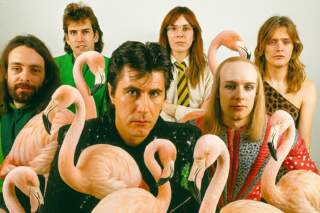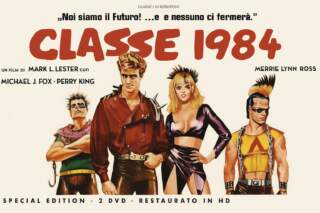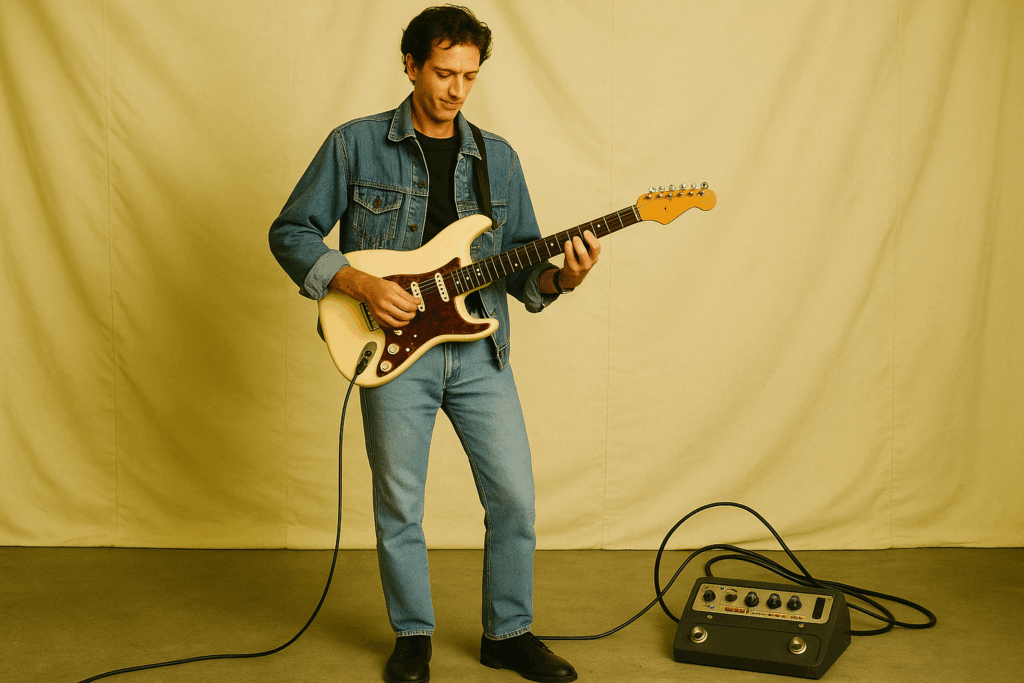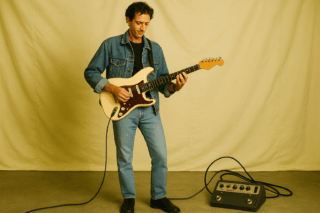La tranquilla provincia americana invasa da caotiche creature verdi a Natale, un lupo mannaro che si trasforma sotto i neon di un peep show, un ragazzino che costruisce un’astronave nel garage: sono solo alcune delle visioni sorprendenti che il cinema di Joe Dante ci ha regalato negli anni ’80.
Regista cinefilo e iconoclasta, Joe Dante ha saputo portare una ventata di ribellione nel cinema popolare di quel decennio, mescolando horror, commedia e satira sociale con uno spirito dissacrante. I suoi film – spesso mascherati da divertimento per famiglie – celano un’anima irriverente, pronta a fare a pezzi i miti dell’American way of life e a omaggiare al contempo la cultura pop e i B-movies che lo hanno formato.
Dante nasce nel 1946 a Morristown (New Jersey) e studia al Philadelphia College of Art. Fin dagli esordi dimostra un’estetica anticonformista: nel 1968 realizza il suo primo lungometraggio, The Movie Orgy, una pellicola sperimentale fiume (circa sette ore di durata) montata assemblando spezzoni di B-movies d’epoca.
Questa operazione-collage, quasi un atto d’amore verso il cinema di serie B, prefigura la cifra stilistica di Dante, che mescolerà il gusto per i vecchi film di genere con la creatività anarchica tipica della controcultura.
Non a caso, dopo gli inizi come montatore di trailer presso la factory di Roger Corman (maestro del low budget), Dante esordisce alla regia collaborando con Corman stesso.
La sua gavetta nel cinema indipendente lo porta a coregiare la commedia pulp Hollywood Boulevard (1976) e poi a dirigere l’horror satirico Piranha (1978), prodotto da Corman.
La consacrazione arriva però a inizio anni ’80 con L’ululato (1981), film grazie al quale attira l’attenzione di Steven Spielberg, che lo invita a dirigere un episodio del kolossal antologico Ai confini della realtà (1983).
Da lì in avanti, nel corso degli anni Ottanta Joe Dante firma una serie di opere originali e imprevedibili – dal successo planetario di Gremlins alle stramberie sci-fi di Explorers, fino alla satira suburbana di L’erba del vicino – che lo impongono come autore di culto. Nei capitoli seguenti ripercorriamo questi film uno per uno, per riscoprire il cinema ribelle con cui Dante ha marchiato a fuoco gli anni Ottanta.
L’ululato (The Howling, 1981)
Dopo il divertissement acquatico di Piranha, Dante affronta il mito del lupo mannaro ne L’ululato, tratto da un romanzo di Gary Brandner. Il film segue una giornalista (Dee Wallace) traumatizzata, che si ritira in una clinica-rifugio sulle colline della California per riprendersi – ignara che i membri della comunità sono in realtà licantropi.
L’ululato è un horror che mischia brividi e ironia, in perfetto stile Dante. La pellicola venne accolta positivamente dalla critica, affermandosi come un thriller dell’orrore acclamato per la sua originalità.
In un anno (il 1981) che vide anche Un lupo mannaro americano a Londra, Dante riuscì a ritagliarsi il suo spazio reinventando la leggenda dei lupi mannari con toni moderni e metacinematografici.
Una cifra distintiva de L’ululato è la sua ricchezza di inside jokes e riferimenti cinefili. Il guru dei B-movie Roger Corman – mentore di Dante – compare in un gustoso cameo (un uomo impaziente in attesa di una cabina telefonica) per strizzare l’occhio agli spettatori più attenti.
Molti personaggi portano nomi ispirati a registi di vecchi film di licantropi (da George Waggner a Terence Fisher) e in una scena appare persino Forrest J. Ackerman, leggendario curatore di Famous Monsters, con in mano una rivista di mostri. L’ironia non toglie efficacia all’orrore: restano memorabili le trasformazioni in lupo, realizzate con spettacolari effetti prostetici da Rob Bottin.
La lunga sequenza in cui il maniaco Eddie Quist muta forma davanti agli occhi terrorizzati della protagonista è un pezzo di bravura gore che Dante orchestra con compiacimento ribelle – indugiando sui dettagli grotteschi – salvo poi dissacrarlo con tocchi beffardi.
L’ibrido di paura e sarcasmo de L’ululato risulta così destabilizzante: da un lato rispetta i canoni del film di mostri (suspense, sangue, ululati alla luna piena), dall’altro li manomette, divertendosi a commentare il genere mentre lo mette in scena.
In questo, Dante dimostra già la sua vena meta: ci spaventa e insieme ci strizza l’occhio. L’ululato chiude su una nota beffarda e amaramente ironica – il mostro esibito in diretta TV, accolto con incredulità dal pubblico – a suggello di un film che graffia con intelligenza la superficie patinata del mainstream.
Ai confini della realtà (Twilight Zone: The Movie, 1983)
Reduce dal successo de L’ululato, Dante viene ingaggiato da Spielberg per partecipare a Ai confini della realtà, ambiziosa rivisitazione cinematografica della celebre serie televisiva The Twilight Zone.
Il progetto, composto di quattro episodi diretti da altrettanti registi (tra cui John Landis e George Miller), rappresenta per Dante l’occasione di lavorare a fianco di Spielberg ma soprattutto di dare libero sfogo alla sua fantasia in un contesto antologico.
L’episodio affidatogli – remake del classico It’s a Good Life – è forse il più bizzarro e visionario del film, e porta inequivocabilmente il suo marchio.
Dante, notato da Spielberg proprio grazie a L’ululato, colse l’occasione per sfoggiare il suo gusto immaginifico: nel suo segmento trasforma la storia inquietante di un bambino onnipotente in un incubo a colori dal tono quasi da fumetto animato.
L’episodio vede una maestra (Kathleen Quinlan) capitare nella casa di un ragazzino dagli inquietanti poteri mentali che tiene “prigioniera” la sua bizzarra famiglia.
Anziché puntare sul terrore puro, Dante opta per una messa in scena iperbolica e caricaturale: la casa si trasfigura in un luna park allucinato, dove ogni desiderio infantile prende vita in modo deformato.
Sullo schermo compaiono conigli demoniaci usciti da cappelli magici, cartoon violenti trasmessi in continuazione, mostri da fumetto che materializzano le paure e i capricci del bambino.
Dante gioca con i colori saturi e gli effetti speciali artigianali per ricreare l’atmosfera di un cartoon dal vivo. Il risultato è uno spettacolo volutamente camp e surreale, che rende omaggio ai Looney Tunes e a Tex Avery mentre racconta una storia da brivido.
Questa giustapposizione audace – horror e humor da cartone animato – spiazza lo spettatore: l’episodio è inquietante ma anche buffo, spaventoso e al tempo stesso esagerato e ironico.
In mezzo ai toni leggeri affiora comunque il sottotesto oscuro della vicenda, ma Dante preferisce far emergere un lato quasi empatico: il piccolo Anthony, più che malvagio, appare come un bambino solo e viziato in cerca d’affetto, e la maestra cercherà di guidarlo. Così, dove la versione televisiva originale era agghiacciante, Dante introduce una nota di tenero ottimismo finale.
Ai confini della realtà permette a Joe Dante di affinare la sua cifra stilistica: It’s a Good Life diventa, sotto la sua guida, un cartone animato live-action, visionario e stravolto, un piccolo saggio pop della sua poetica visiva.
Non stupisce che proprio Spielberg – rimasto colpito dal talento visionario di Dante – gli affiderà subito dopo il progetto che lo renderà celebre nel mondo intero.
Gremlins (1984)
Un graffito raffigurante Gizmo, il tenero mogwai protagonista di Gremlins (1984). L’iconico contrasto tra la dolcezza di Gizmo e la malizia distruttiva dei gremlin incarna l’approccio dissacrante di questo film.
Se E.T. di Spielberg ci aveva mostrato l’alieno buono come amico dei bambini, Gremlins di Joe Dante – prodotto dallo stesso Spielberg – arriva come un cavallo di Troia a sabotare il cinema natalizio e il fantasy per famiglie. Scopri Gremlins nella recensione dedicata di Spazio 1984.
Explorers (1985)
Sull’onda del successo di Gremlins, a Dante viene data carta bianca per un progetto profondamente personale: Explorers. Se Gremlins giocava con l’horror, Explorers vira verso la fantascienza avventurosa, ma sempre filtrata attraverso lo sguardo scanzonato e irriverente del regista.
La storia segue tre ragazzini (interpretati da Ethan Hawke, River Phoenix e Jason Presson) accomunati dall’amore per i film di fantascienza e la tecnologia: guidati da strani sogni in cui vedono circuiti elettronici, i tre costruiscono nel garage un’astronave artigianale con materiali di recupero, riuscendo incredibilmente a volare nello spazio.
Nella prima parte il film è un’ode alla fantasia infantile e al potere dell’immaginazione nerd: Dante tratteggia con affetto l’ambiente suburbano in cui i protagonisti crescono a pane e war movies, fumetti e vecchi sci-fi anni ’50 trasmessi in TV a tarda notte.
Explorers sembra iniziare come un E.T. in salsa teen, celebrando lo stupore della scoperta e il sogno di ogni ragazzino appassionato di sci-fi. È però nella seconda parte che Dante spiazza le aspettative e mostra la sua vena più giocosa e ribelle. I tre giovani explorers, giunti all’interno di un misterioso astronave aliena, scoprono che i temuti extraterrestri non sono affatto minacciosi invasori: sono due adolescenti alieni pasticcioni e iperattivi, che hanno intercettato le trasmissioni televisive terrestri e hanno imparato l’inglese (e i costumi umani) esclusivamente guardando vecchi film, cartoni animati e spot pubblicitari degli anni ‘50-’60!
Questa rivelazione dà il via a una serie di scene folli: gli alieni comunicano quasi soltanto a colpi di citazioni da show televisivi e B-movie, comportandosi come caricature dei terrestri.
In pratica Dante materializza letteralmente gli effetti della cultura pop sullo schermo – gli alieni sono un collage vivente di campionario televisivo terrestre.
È una trovata metacinematografica audace: invece del classico incontro ravvicinato pieno di meraviglia o terrore, ci troviamo davanti a una buffoneria surreale, quasi uno sketch di varietà spaziale.
La scena in cui uno degli alieni, alla vista degli umani, esclama “Hi ho, Silver!” imitando un cowboy dei serial western, o quando intona un jingle pubblicitario anni ’60, sono esempi del humor citazionista di Dante al suo apice.
Non tutti compresero all’epoca questo radicale cambio di tono: Explorers fu un fiasco al botteghino e lasciò spiazzati molti critici, anche a causa di un montaggio affrettato imposto dallo studio.
Uscito nell’estate 1985 in contemporanea con eventi come il Live Aid e concorrenti blockbuster del calibro di Ritorno al futuro, il film venne rapidamente oscurato e floppò nelle sale.
Dante stesso ha rivelato che la versione distribuita era incompleta e che la Paramount lo costrinse a chiudere la post-produzione in fretta.
Tuttavia, col passare degli anni Explorers è stato rivalutato: grazie all’home video ha guadagnato uno status di cult presso i fan della fantascienza fantasiosa.
In retrospettiva, Explorers appare come un’opera sui sogni e sul cinema stesso, un omaggio ai ragazzini che sognano guardando i film (e infatti la struttura stessa ricorda un sogno che devia in direzioni inaspettate).
Dante, con il suo consueto gusto eclettico, fonde la meraviglia spielberghiana della prima metà con la parodia sfrenata della seconda, creando un ibrido unico.
Forse Explorers era troppo in anticipo sui tempi – anticipando quell’approccio postmoderno che mescola alto e basso, venerazione e presa in giro del genere.
Rivisto oggi, Explorers diverte e sorprende per il suo carattere imprevedibile: è un film imperfetto ma genuinamente ribelle, che non ha paura di virare dal romanzo di formazione all’autoironia demenziale pur di restare fedele allo spirito libero del suo autore.
Donne amazzoni sulla Luna (Amazon Women on the Moon, 1987)
Tra Explorers e il suo film successivo, Dante si cimenta anche in un progetto atipico e collettivo: Donne amazzoni sulla Luna (titolo italiano di Amazon Women on the Moon).
Si tratta di un film a episodi, una commedia a sketch realizzata a più mani da vari registi, tra cui John Landis, Carl Gottlieb e lo stesso Joe Dante.
Un vero “film collettivo”, dunque, che omaggia e parodizza i B-movie fantascientifici anni ’50 mescolandoli con sketch satirici sulla TV.
La cornice è la finta messa in onda notturna di un vecchio film sci-fi (Amazon Women on the Moon, appunto) su un canale locale: il film viene continuamente interrotto da zapping fra altri programmi assurdi, pubblicità demenziali e brevi segmenti comici, componendo un collage di puro nonsense.
Un concept del genere era terreno fertile per Dante, che della cultura trash televisiva è da sempre un amante ironico.
Nel calderone anarchico di Donne amazzoni sulla Luna, Dante dirige alcuni segmenti che portano la sua impronta surreale. Ad esempio, lo sketch “Murray in Videoland” (accreditato però a Robert K. Weiss) ricorda certe trovate di Dante, mostrando un uomo intrappolato fisicamente dentro il segnale televisivo, in balia dei programmi che cambiano.
Oppure “Commerciali da incubo”, falsi spot dove Dante può dar libero sfogo alla satira (come quello sui libri a pagamento per imparare a rimorchiare le donne, con tanto di presentatore imbroglione).
Non tutti gli episodi sono suoi, ma lo spirito generale dell’operazione – demenziale, cinefilo e ribelle – è perfettamente allineato con la sua sensibilità.
Il segmento principale, che dà il titolo al film, è la parodia di un immaginario film fantascientifico anni ’50 con effetti speciali volutamente poveri e situazioni ridicole (le “donne amazzoni sulla Luna” seminude che attaccano gli astronauti).
Dante e soci ricreano con affetto e sarcasmo la goffaggine adorabile di certo cinema d’altri tempi, ma la inseriscono in un contesto contemporaneo di comicità irriverente e senza freni.
Donne amazzoni sulla Luna uscì in sordina nel 1987 e rimane un’opera minore e poco conosciuta, ma rappresenta un tassello curioso nella filmografia di Dante. È come se il regista, tra due produzioni hollywoodiane importanti, si fosse concesso un intermezzo underground per dare sfogo puro al proprio amore per il kitsch e la parodia televisiva.
In effetti, lo schema a zapping del film ricorda molto The Movie Orgy, la sua pellicola d’esordio collage: ancora una volta Dante dimostra la sua natura da DJ del cinema, mixando spezzoni di trash e di nostalgia cinefila in un flusso anarchico.
Per il pubblico italiano il film resta quasi invisibile (inedito nei cinema, circolato forse in home video con il suo titolo bizzarro), ma per i cultori è un autentico oggetto di culto. Pur essendo un lavoro collettivo, l’episodio testimonia la coerenza di Dante nel perseguire una comicità irriverente anche fuori dai circuiti mainstream.
Salto nel buio (Innerspace, 1987)
Nel 1987 Dante torna a un cinema di più ampio budget con Salto nel buio (Innerspace), prodotto dalla Amblin di Spielberg.
Si tratta di una commedia fantascientifica che rilegge in chiave pop il classico tema del “viaggio fantastico all’interno del corpo umano”.
Il film è ispirato a Fantastic Voyage (1966), ma mentre quel precedente era serissimo, Salto nel buio ne rappresenta la versione scatenata e umoristica, perfettamente in linea con la personalità di Dante.
La trama di Salto nel Buio vede un pilota collaudatore, Tuck (Dennis Quaid), miniaturizzato a bordo di un sottomarino microscopico e iniettato per errore nel corpo di Jack (Martin Short), un ipocondriaco commesso di supermercato. Da questa premessa rocambolesca si dipana una doppia avventura: all’interno del corpo, Tuck naviga tra organi e globuli; all’esterno, Jack cerca di sfuggire a un gruppo di criminali industriali che vogliono impossessarsi della tecnologia di miniaturizzazione.
Con Salto nel Buio, Dante modula abilmente action, fantascienza e comicità slapstick, regalando un film dal ritmo forsennato.
Salto nel buio si distingue per gli effetti speciali sorprendenti – realizzati dalla Industrial Light & Magic – che all’epoca furono all’avanguardia.
Le sequenze dentro il corpo umano (dalle pareti dello stomaco alle valvole cardiache) sono visivamente inventive e uniscono meraviglia e ironia. Per esempio, Tuck osserva stupito il gigantesco cuore di Jack pulsare a ritmo, oppure ammira l’aurora boreale della retina dall’interno dell’occhio: momenti di sci-fi genuina subito punteggiati però da gag (come Jack che, sentendo solletico dall’interno, starnutisce violentemente facendo rischiare a Tuck l’espulsione).
Questa continua alternanza di registri – tensione e risata – è orchestrata con maestria da Dante, anche grazie all’ottima verve comica di Martin Short, vero mattatore del film.
L’attore offre un’interpretazione esilarante dell’uomo qualunque travolto dagli eventi, con spassosi tic e momenti di follia (celebre la scena in cui Jack, guidato da Tuck, deve fingere di essere un arrogante cowboy texano e subisce un’iperbolica trasformazione facciale cartoon grazie alle diavolerie tecnologiche all’interno del suo corpo).
Sotto la patina da avventura per famiglie, Salto nel buio nasconde ancora una volta qualche zampata satirica à la Dante. I “cattivi” del film – industriali senza scrupoli e scienziati deviati – sono rappresentati in modo volutamente caricaturale, quasi fossero uscite da un fumetto: uno su tutti, il killer interpretato da Vernon Wells, dotato di un braccio robotico intercambiabile con ogni tipo di arma, è una parodia vivente dei villain hi-tech.
Dante strizza l’occhio anche al cinema che lo ha preceduto: in una scena appare l’attore Kevin McCarthy (protagonista di L’invasione degli ultracorpi del 1956) che, vedendo Jack inseguito dal minuscolo pod di Tuck, urla per strada «È vero! È tutto vero!», replicando esattamente il suo celebre finale nel classico di Don Siegel – un cameo meta-cinematografico che i fan hanno adorato. Queste chicche dimostrano come Dante, pur lavorando in una grossa produzione, non rinunci mai al suo bagaglio cinefilo e alla voglia di giocare.
Salto nel buio fu accolto bene dalla critica e si rivelò un successo moderato al box office (non ai livelli di Gremlins, ma dignitoso). Soprattutto, il film ottenne un importante riconoscimento: vinse l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 1988, a coronamento di uno sforzo tecnico notevole per l’epoca.
Per Dante fu la conferma di poter coniugare il suo stile scanzonato con il cinema commerciale di qualità.
In mezzo a tanti blockbuster seriosi della fine degli anni ’80, Salto nel buio spicca per la sua leggerezza intelligente: è un film che fa divertire con ritmo e fantasia, ma tra le righe suggerisce anche un messaggio umano (il timido Jack trova coraggio e fiducia in sé grazie all’esperienza).
Pur essendo forse l’opera più lineare e meno sovversiva di Dante nel decennio, Salto nel Buio conserva comunque quella freschezza anticonformista – pensiamo al finale non convenzionale, con un cliffhanger fumettistico e la canzone “Twistin’ the Night Away” a sdrammatizzare – che lo rende figlio autentico del suo autore.
L’erba del vicino (The ’Burbs, 1989)
I protagonisti de L’erba del vicino (1989) durante un appostamento notturno nel loro tranquillo quartiere di periferia. Con questo film Joe Dante trasforma la quiete suburbana in un teatro di paranoia ed esilaranti eccessi, smascherando le nevrosi nascoste dietro la facciata del sogno americano.
A chiudere la straordinaria corsa anni ’80 di Joe Dante arriva L’erba del vicino, una commedia nera ambientata in un’idilliaca strada di periferia americana dove, dietro prati all’inglese e steccati bianchi, si annidano sospetti e (forse) mostruosi segreti.
Protagonista è Ray Peterson (Tom Hanks), padre di famiglia stressato e in cerca di relax casalingo, che invece di andare in vacanza decide di trascorrere qualche giorno a oziare a casa.
L’ozio però è turbato dai nuovi vicini: i Klopek, una strana famiglia che vive in una casa fatiscente e inquietante, da cui provengono rumori molesti e comportamenti sospetti.
Ray, insieme agli amici vicini – l’entusiasta complottista Art (Rick Ducommun) e il bellicoso veterano Mark (Bruce Dern) – inizia a sorvegliare i Klopek, convinto che stiano tramando qualcosa di sinistro.
La situazione degenera in una spirale di paranoia e follia collettiva: gli improvvisati investigatori scambiano ogni gesto dei Klopek per prova di attività macabre (dal sacco dell’immondizia “insanguinato” al seminterrato che si illumina di notte) e arrivano persino a introdursi in casa loro durante un’assenza, combinando un disastro.
L’erba del vicino è un film dall’umorismo oscuro e graffiante, in cui Dante riversa la sua vena satirica contro il conformismo e la paura del diverso nella suburbia americana.
Il tono è da farsa noir: la pacifica vita di quartiere viene rappresentata in modo volutamente caricato, quasi fosse un cartone animato (non a caso, ad apertura film vediamo il logo Universal tramutarsi in un globo terrestre su cui la camera zooma fino a entrare in una tipica cittadina – un tocco da cartoonist).
I personaggi dei vicini sono figure sopra le righe, caricature amorevoli dei tipici americani medio-borghesi: c’è il panzone invadente e credulone, il militare patriottico fanfarone, il giovanotto scansafatiche (Corey Feldman) che osserva tutto come fosse uno spettacolo.
Dante li ritrae con affetto ma anche con spirito sarcastico, mostrandone le piccolezze e i pregiudizi.
I Klopek incarnano alla perfezione l’outsider bizzarro che scatena la psicosi del “vicino mostro”: sono taciturni, eccentrici (il giovane Klopek è patologo e colleziona teschi e dipinti macabri), vivono isolati – abbastanza per far esplodere la fervida immaginazione dei protagonisti.
Durante tutto il film, Dante gioca abilmente sul filo che separa realtà e paranoia, tenendo il pubblico in bilico: questi Klopek saranno davvero pericolosi assassini oppure sono solo vittime dell’ossessione dei vicini impiccioni? Il crescendo conduce a scene esilaranti e insieme ricche di tensione: come l’incubo onirico di Ray in cui sogna un rituale satanico dei Klopek, o la perquisizione clandestina della casa che finisce con un’esplosione catastrofica.
Nel finale, L’erba del vicino riserva un colpo di scena che capovolge la prospettiva (rivelando che forse qualche scheletro nell’armadio i Klopek ce l’hanno davvero) ma ciò che resta impresso è soprattutto il messaggio satirico.
In un monologo arrabbiato, Ray sbotta contro i propri compari: «Noi siamo i mostri! Noi siamo quelli fuori di testa in questa storia…», ammettendo che la loro crociata è stata irrazionale e violenta.
È un momento chiave in cui Dante sembra denunciare – pur nel paradosso comico – la pericolosità della mentalità NIMBY, delle paure infondate che generano mostri laddove non ce ne sono.
Certo, subito dopo il film reintroduce un elemento macabro reale per chiudere in bellezza horror, ma quella battuta rimane come stoccata critica.
Con L’erba del vicino, Dante realizza forse la sua satira più esplicita alla America bene. Il film, tuttavia, inizialmente non ebbe fortuna commerciale: uscito nell’inverno 1989, fu accolto tiepidamente in patria e in Italia non arrivò nemmeno nei cinema, distribuito solo in VHS.
Il pubblico probabilmente si aspettava una commedia leggera con Tom Hanks, trovandosi invece di fronte a un’opera bizzarra, venata di dark humor e momenti quasi horror.
Col tempo, però, The ’Burbs (questo il titolo originale, giocoso diminutivo di suburbs) è stata rivalutata ed è diventata un cult movie, specie all’estero.
Molti hanno riconosciuto l’abilità di Dante nel mescolare il dark al comedy in modo efficace e il film oggi è citato come una delle satire più riuscite sul lato oscuro della provincia USA.
Stilisticamente, Dante con L’Erba del Vicino è in stato di grazia: dirige il quartiere come un microcosmo teatrale, con movimenti di macchina sinuosi tra le casette, e mantiene un equilibrio precario tra risata e suspense. Emblematico è l’uso della colonna sonora di Jerry Goldsmith, che alterna temi da sit-com a improvvisi inserti alla Ennio Morricone (fischi da spaghetti-western quando i vicini si affrontano come in duello) – un pastiche sonoro che rispecchia il tono volutamente sopra le righe del film.
In L’erba del vicino, la vena ribelle di Dante si manifesta nella distruzione satirica del placido sogno suburbano: come è stato detto, il regista prende un “tagliaerba” metaforico al rassicurante prato del Sogno Americano, svelando le paranoie e l’idiozia che possono celarsi dietro la rispettabilità. Lo fa senza cinismo: i suoi personaggi, pur sciocchi e sbandati, sono trattati con humor affettuoso, come figure di un cartoon umano.
In fondo Dante non parteggia né per i conformisti né per i weirdos: li mette tutti sullo stesso piano di follia bonaria, mostrando che il vero nemico è la paura irrazionale.
L’erba del vicino chiude così gli anni ’80 danteschi con un’esplosione (letteralmente) di risate e brividi, confermando Joe Dante come un giullare del cinema americano, capace di divertirci e al contempo farci riflettere sui nostri stessi mostri quotidiani.
Anni ’80 tra amore per il cinema e la ribellione

Dagli esordi colti e sperimentali sino ai trionfi hollywoodiani, gli anni Ottanta di Joe Dante rappresentano una stagione cinematografica unica, in cui un autore dal cuore cinefilo e dall’animo ribelle è riuscito a inserirsi nel mainstream senza perdere la propria identità. Joe Dante ha saputo infondere nei suoi film di quel decennio un inconfondibile mix di elementi: l’amore per i B-movie degli anni ’50, lo spirito irriverente della controcultura anni ’60 e l’umorismo anarchico dei cartoon. Questa formula ha dato vita a opere che mescolano paura e sorriso, critica e intrattenimento, in un continuo gioco di riferimenti pop.
Se registi come Spielberg incantavano con la magia e il potere dell’innocenza, Dante faceva capolino alle loro spalle, scompigliando i capelli al cinema commerciale e sussurrandogli all’orecchio che anche nelle favole c’è spazio per un po’ di sano caos.
I suoi film degli anni ’80 – da L’ululato a Gremlins, da Explorers a L’erba del vicino – sono diventati per molti versi dei cult, amati proprio per quella loro natura sui generis.
Oggi riconosciamo in Dante un precursore di certo cinema postmoderno: il suo gusto citazionista e ludico ha aperto la strada a registi delle generazioni successive (si pensi a Quentin Tarantino o Edgar Wright, anche loro cresciuti con i ritmi sincopati della TV e i rimandi alla serie B). Al di là delle influenze, l’eredità più preziosa che ci ha lasciato il cinema anni ’80 di Joe Dante è forse un invito alla libertà creativa. Le opere di quel periodo ci ricordano che si può fare spettacolo intelligente senza prendersi troppo sul serio, che si può essere sovversivi col sorriso sulle labbra.
Dante ci insegna a guardare i mostri – siano essi lupi mannari, gremlin o vicini di casa sospetti – con uno spirito giocoso e critico allo stesso tempo, perché spesso dietro la facciata dell’orrore si nasconde una verità satirica, e dietro una risata si cela una piccola rivoluzione.
Negli anni Ottanta il cinema ribelle di Joe Dante ha brillato come un oggetto strano e luminoso, un gremlin impazzito nella macchina dei blockbuster: un monello irriverente che ancora oggi, a riguardarlo, non ha perso un briciolo della sua energia anticonformista.
Fonti:
- Biografia di Joe Dante su Film.it film.itfilm.it
- SlashFilm – How Gremlins’ Infamous Christmas Story Made It Into the Film slashfilm.com
- Wikipedia (en) – Joe Dante en.wikipedia.org
- Horror Italia 24 – Approfondimento su L’erba del vicino horroritalia24.ithorroritalia24.it
- Jonathan Rosenbaum – Joe Dante’s Purgatory (analisi critica) jonathanrosenbaum.netjonathanrosenbaum.net
- Milwaukee Magazine
- IMDb