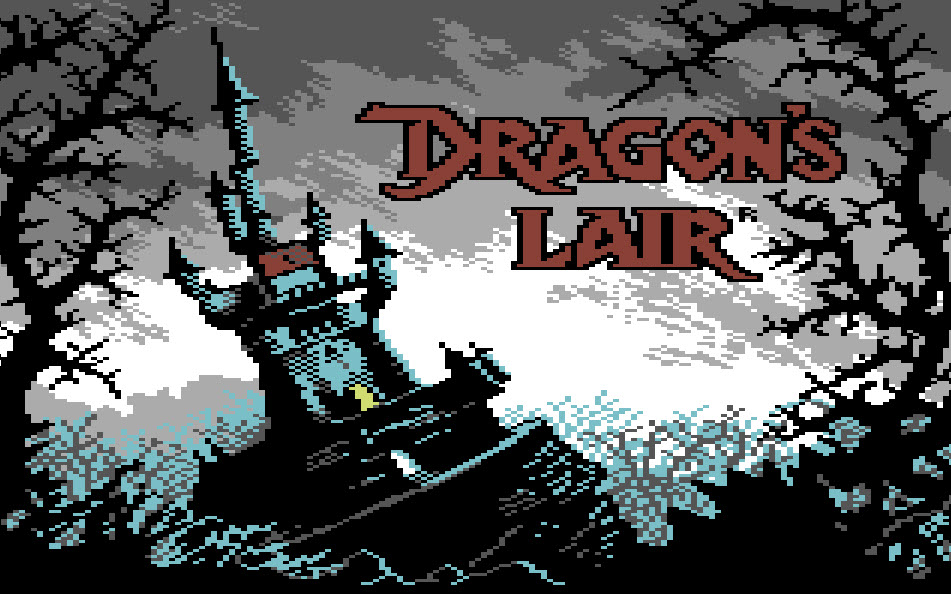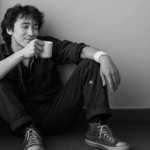Nella storia del cinema d’animazione, pochi nomi riescono a sollevare discussioni tanto accese quanto quello di Don Bluth. Per alcuni, un visionario che ha osato sfidare l’impero di Walt Disney; per altri, un minatore del subconscio infantile armato di palette cromatiche sinistre e conigli antropomorfi dalle orbite vuote.
Ma la domanda legittima che oggi ci poniamo — con spirito critico, metodo, e auricolari ben infilati — è: Don Bluth è dannoso?
La risposta, come spesso accade nella forma d’arte dell’analisi culturale, è: dipende. Ma se siete arrivati fin qui, non è certo per ricevere un “dipende”.
Volete evidenze scientifiche, dati, strane immagini, riferimenti ai laser disc e magari anche un collegamento nascosto con Toy Story, anche se non centra una cippa.
Ebbene, accomodatevi: questo articolo non solo analizzerà la carriera di Don Bluth, ma cercherà di comprendere come, attraverso i sogni che ha animato (e i traumi che ha causato), egli abbia inciso a fuoco un’epoca. O forse l’abbia rovinata, dipende da come butta il vostro sistema nervoso centrale.
Capitolo I – Nascita di un’ossessione: data di un destino
Don Bluth nasce il 13 settembre 1937 a El Paso, Texas. La data, in sé, potrebbe sembrare neutra. Ma non lo è. Quel 13 settembre cade sotto la protezione astrologica della Vergine: segno notoriamente perfezionista, che forse spiega la fissazione di Bluth per le animazioni iper-dettagliate, dove anche la palpebra di un roditore in preda al panico vibra come il pensiero di un ansioso cronico in pieno esame universitario.
All’età di sei anni, Bluth vede Biancaneve e i sette nani. Qui accade il primo punto di rottura: l’incontro con l’animazione come forma d’arte. Ma mentre altri bambini volevano solo sapere se il Principe avesse una casa, Don comincia a disegnare.
Gli gnomi diventano cavalli; i cavalli, pipistrelli; i pipistrelli, creature vagamente simili a quelle che, anni dopo, avrebbero popolato Brisby e il segreto di NIMH, film che rimane una delle più alte manifestazioni della filosofia del “carino terrificante”.
Capitolo II – Walt Disney: padre, padrone, fantasma
Nel 1955, Don Bluth inizia a lavorare come intercalatore per Disney. Il giovane Don ha vent’anni, un’ossessione per i personaggi interessanti e un’innata capacità di dare espressioni oculari ai roditori. Ma nel 1957 abbandona temporaneamente il mondo dell’animazione per… allevare cavalli!
Una pausa comprensibile, se consideriamo che i telefoni dell’epoca erano ancora a rotella e le comunicazioni con Hollywood passavano spesso per il codice Morse. Ma Don torna. E quando torna, lo fa come se fosse stato ibernato in criogenia narrativa.
Nel 1979, con un manipolo di animatori disillusi, Bluth lascia Disney per fondare un proprio studio. Un atto eroico? Una scissione necessaria? O l’inizio di un’era dannosa?
Capitolo III – L’animazione prende fuoco: Brisby e il segreto dell’angoscia
- Brisby e il segreto di NIMH esce al cinema. I bambini americani, abituati a topi simpatici con guanti bianchi, si trovano davanti a un’opera gotica, popolata da corvi ossessivo-compulsivi, ratti che parlano di eutanasia, e colori che sembrano emersi da un incubo vittoriano alimentato a clorofilla.
Il film è oggettivamente un capolavoro. Ma qui iniziano le prime evidenze scientifiche di un possibile effetto collaterale: l’esposizione prolungata alle animazioni di Don Bluth può alterare lo sviluppo dell’emisfero destro, causando sogni ricorrenti in cui un gufo gigante ti spiega la tassazione progressiva.
Non è un caso che, in numerose interviste, studiosi di semiotica abbiano comparato NIMH a Nosferatu in versione roditore. Persino Walt Disney, da qualche parte nell’aldilà, avrebbe detto: “Troppa roba.”
Capitolo IV – Laser Disc e spasmi visivi: l’era dei videogiochi
Nel 1983, mentre nel mondo impazzano i Walkman e si iniziano a intravedere i primi auricolari stereo, Don Bluth crea Dragon’s Lair. Un videogioco su Laser Disc — tecnologia avveniristica quanto scomoda — che permette animazioni da film in una sala giochi.
Il giocatore non gioca realmente: assiste, mentre il cavaliere Dirk muore in loop in almeno 47 modi diversi.
Giocare a Dragon’s Lair non è mai stato un’esperienza rilassante. È più simile a un esperimento neurologico: riflessi, ansia, occhi spalancati come fessure cosmiche.
Gli effetti collaterali? Numerosi. Disorientamento visivo. Sudorazione palmare. Ricerca compulsiva di nuovi gettoni.
I genitori più attenti iniziarono a sconsigliare la visione (e il gioco) dei laser disc di Don Bluth ai bambini sotto i dieci anni, o a chiunque fosse predisposto agli attacchi di panico a causa di strane immagini animate.
Capitolo V – L’infanzia minacciata: Fievel, Balto e l’esodo del trauma
Negli anni Ottanta e Novanta, Bluth continua con film come Fievel sbarca in America, In viaggio con Pippo (ah no, quello era un altro), Alla ricerca della Valle Incantata, e Balto.
Questi film parlano tutti di viaggi, separazioni, animali antropomorfi e sogni che muoiono in un campo di grano sotto la neve. Il tutto accompagnato da colonne sonore struggenti che, secondo recenti studi, avrebbero contribuito a una generazione di adulti attratti dalla malinconia in musica. Coincidenza? O esiste un nesso causale tra Fievel e la diffusione degli Smiths tra i trentenni post-hipster?
Il futuro dei bambini spettatori? Incerto. Alcuni sviluppano un’empatia feroce. Altri, invece, sono convinti che se lasci le animazioni di Don Bluth sempre accese su una TV senza audio, essa diventi un portale per dimensioni ultracosmiche abitate da gufi parlanti.
Capitolo VI – Don Bluth contro Toy Story: la vendetta della plastica
Quando Toy Story arriva nel 1995, l’animazione cambia per sempre. Il computer vince, la plastica trionfa sulla matita. Don Bluth risponde con film come Titan A.E.: un’epopea post-apocalittica che tenta di affrontare Pixar a colpi di laser e filosofia esistenziale.
Ma c’è un problema: Toy Story è fresco, brillante e ha personaggi interessanti con conflitti interiori credibili. I film di Bluth, al confronto, sembrano il frutto di una ricerca filosofica sulla decadenza dello spirito occidentale in forma di procione.
La domanda che si fa largo tra gli analisti è: Don Bluth emette radiazioni? La risposta è no. Ma, se intesa metaforicamente, la sua opera sprigiona una forza destabilizzante tale da confondere i sensi e stimolare domande scomode sul senso della vita.
Capitolo VII – La riscoperta: culto, meme, università
Oggi, Don Bluth è venerato come una figura quasi esoterica. I suoi film vengono analizzati nelle università. Le sue animazioni vivono su YouTube, remixate con musica elettronica e audiocassette sovrapposte a immagini glitchate. Le sue VHS sono oggetti di culto, le sue strane immagini stampate su t-shirt ironiche.
La sua dannosità, in fondo, è quella delle cose geniali: spiazzare, disturbare, imprimersi nella mente. Proprio come certi sogni che non si riescono a dimenticare, o certi telefoni pubblici degli anni ’90 che ti restituivano l’eco della tua voce come se venisse da un’altra dimensione.
Don Bluth oggi insegna. Lavora a nuovi progetti. È stato riscoperto. E come accade ai grandi poeti o ai monaci pazzi, ciò che prima appariva pericoloso ora viene studiato come oracolo.
Don Bluth è dannoso?
Don Bluth è dannoso? La domanda resta aperta. Ma in un’epoca in cui l’animazione è spesso un derivato zuccheroso di esigenze di marketing, la sua opera — densa, inquietante, imperfetta — è una testimonianza unica.
Non è la forma d’arte che ci aspettavamo. È quella che ci meritavamo. E come ogni forma d’arte autentica, ci mette di fronte a noi stessi. Con occhi grandi, orecchie da topo e un destino scritto su un laser disc.
Non guardate più di 24 ore a fila le animazioni di Don Bluth. Ma se proprio non resistete, ogni tanto spegnete le luci, pompate al massimo la musica e lasciatevi attraversare il cervello da un gufo parlante. È anche questo, in fondo, il futuro dell’animazione.
E forse, anche della nostra salute mentale.