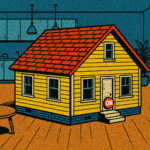Nel cuore pulsante del decennio più ossessionato dall’apparenza, dalla tecnologia e dalla nostalgia del futuro, un anno brillava come una paillette sotto i riflettori di un club new wave: il 1984.
Se quell’anno fu il golden year dei Duran Duran, non fu solo per la loro estetica impeccabile o i videoclip in rotazione continua su MTV, ma per un’alchimia in cui musica, politica, tecnologia e crisi economiche si fusero in una narrazione globale.
I Duran Duran nel 1984 erano più di una band: erano un’icona globale, una promessa sintetica di sogni esotici, una risposta patinata alla recessione e alla paranoia di una società spaventata dall’imminente distopia.
Il loro nome, strappato alle pagine della fantascienza di Barbarella (quel Dottor Durand Durand di Roger Vadim), già suggeriva un’affiliazione al futuro: post-umano, erotico, elettronico.
Nulla di casuale in quell’identità. Come un’Apple pronta a lanciare il suo primo Macintosh con uno spot diretto da Ridley Scott durante il Super Bowl, anche i Duran Duran rappresentavano una nuova interfaccia: interattiva, visiva, sintetica.
In quel 1984, la cultura pop e il marketing si fondevano e la musica diventava merce spettacolare, ma anche mito collettivo.
Il 1984 dei Duran Duran è segnato da un titolo solo: “Arena (An Absurd Notion)”, album dal vivo che li consacra definitivamente come band da stadio, mentre il singolo “Wild Boys” (vero atto di forza techno-tribale) esplode in tutto il mondo.
Scritto con Nile Rodgers e prodotto da Alex Sadkin, “Wild Boys” è un inno tribale e post-apocalittico, degno di una pellicola come Terminator, che in quello stesso anno scuoteva le sale cinematografiche con la sua visione cupa e cyborgizzata del futuro.
I Duran proponevano un’altra estetica del domani: elegante, sensuale, ma intrisa della stessa inquietudine esistenziale.
Mentre Ronald Reagan proclamava “Morning in America” e guidava il paese fuori dalla recessione a colpi di neoliberismo e retorica patriottica, i Duran Duran erano già oltre, proiettati in una galassia di moda, arte e videoclip.
Il Regno Unito, loro patria, navigava tra gli scioperi dei minatori e i fantasmi post-thatcheriani. Ma bastava un video girato nello Sri Lanka, un riff di basso funkeggiante o un falsetto ben posizionato per dimenticare la disoccupazione.
In Italia, i Duran Duran erano più di un culto: erano un’epifania. Il loro passaggio al Festival di Sanremo – pagato, si sussurra, con un cachet superiore ai 120 milioni di lire – fu una tempesta di urla e bandiere, di lacrime e mimesi.
I giornali titolavano sulla “Duranmania” e nei bar si litigava se fosse più bello Simon Le Bon o John Taylor. In realtà, il più affascinante era il loro ruolo semiotico: simboli viventi di un’estetica postmoderna, capaci di trasformare una canzone pop in un’esperienza totale.
Qual è la canzone più famosa dei Duran Duran? Forse “Hungry Like the Wolf”, con il suo video colonialista girato tra tigri e giungle tropicali, o “Rio”, con il suo yacht e il suo sax lisergico. Ma nel 1984, la risposta era una sola: “The Reflex”. Remissata da Nile Rodgers, conquistava le classifiche in America e nel Regno Unito, diventando il primo vero successo planetario di una band inglese post-Beatles. Era la dimostrazione che anche in un mondo governato dai synth, il groove contava ancora.
Nel frattempo, il progetto parallelo Arcadia, nato tra Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor, prendeva forma come una deviazione artistica e più oscura, un laboratorio di suoni che anticipava le atmosfere oniriche e oscure di fine decennio. Il loro singolo “Election Day” sarebbe arrivato l’anno dopo, ma nel 1984 l’idea era già in gestazione: segno che i Duran Duran non erano solo una macchina da soldi e moda, ma anche sperimentatori inquieti, in cerca di nuovi linguaggi.
In quell’anno, ovunque si ascoltava “I Just Called to Say I Love You” di Stevie Wonder, manifesto della melassa pop che commuoveva le masse. Ma chi voleva qualcosa di più tagliente, danzava sulle note di “Union of the Snake” o si lasciava ipnotizzare dalle atmosfere notturne di “New Moon on Monday”. I Duran Duran erano ovunque, ma sempre un passo oltre, sempre un po’ più lontani.
E quando i Duran vennero in Italia? Spesso, ma mai abbastanza. Il loro legame con il Bel Paese era autentico e carnale, fatto di televisione, moda, passaggi obbligati in programmi cult e concerti memorabili. Ma anche di copertine su Ciao 2001, articoli su TV Sorrisi e Canzoni, e poster che tappezzavano le camerette di una generazione in cerca di idoli lontani dalla realtà opprimente del quotidiano.
Il 1984 non fu solo l’anno dei Duran Duran: fu l’anno in cui la musica divenne spettacolo globale, in cui l’estetica vinse sull’etica, in cui ogni videoclip era un manifesto visuale.
I Duran Duran seppero incarnare quel cambiamento con una consapevolezza rara. Non erano semplici ragazzi in giacca di pelle e capelli cotonati: erano l’interfaccia sensibile di un mondo che cambiava, il sottofondo ritmico di una società che voleva ballare per dimenticare.
In fondo, mentre Orwell aveva immaginato un 1984 grigio e oppressivo, i Duran Duran lo avevano dipinto con colori neon, synth esplosivi e sogni esotici. E forse proprio per questo li amiamo ancora.