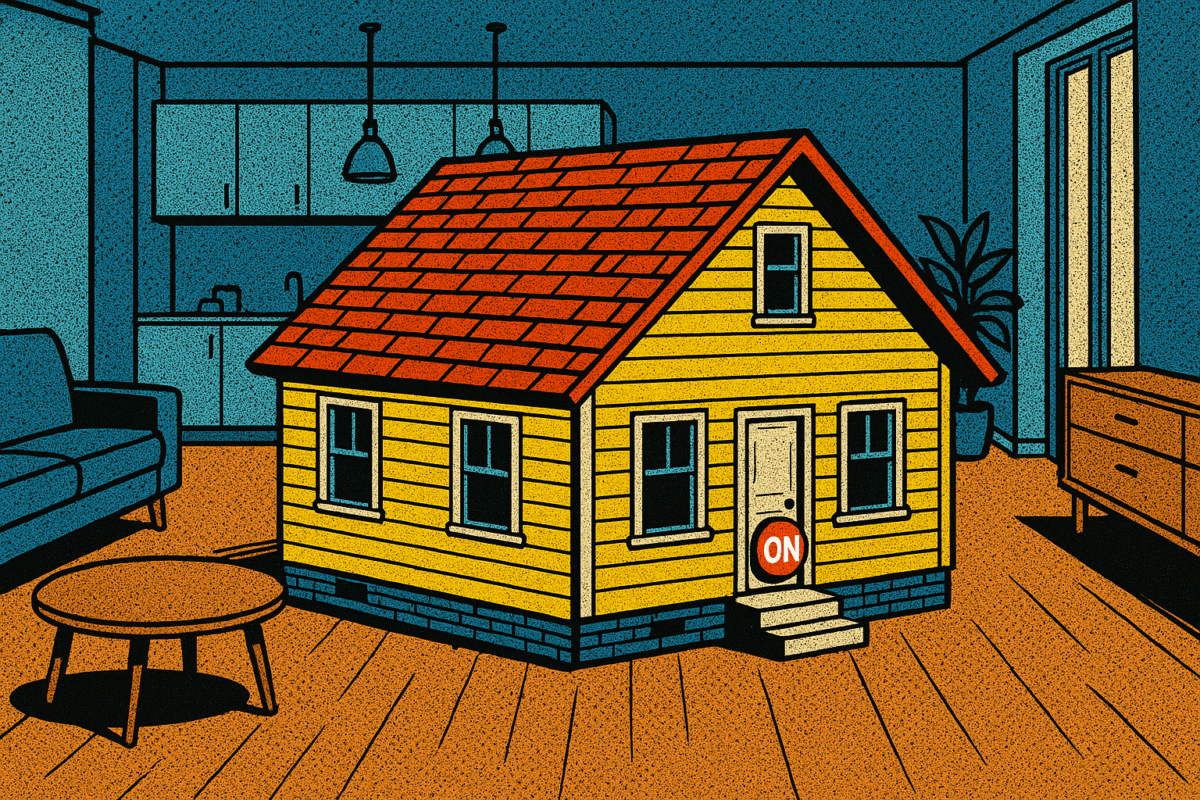Negli anni Ottanta, tutto sembrava funzionare. Il videoregistratore Betamax registrava. Il Commodore 64 caricava i giochi (a volte). La lavatrice Whirlpool girava e cantava. Il fatto che funzionasse era, per il cittadino medio dell’Occidente consumista, garanzia sufficiente di bontà, progresso e civiltà.
Tutto ciò che era funzionale sembrava indistruttibile. Si vendeva lo “stereo a tre pezzi” con tanto di equalizzatore a LED e – per chi osava – a doppia piastra. Si annunciava l’arrivo del futuro tramite il telecomando a infrarossi. Nessuno, però, si domandava quanto fosse scalabile il mangianastri, né se il forno a microonde avesse sufficiente resilienza in caso di blackout.
La qualità non si vedeva, e quindi si dava per scontata. Non c’era bisogno di parlarne: si presumeva.
Delle cose invisibili che si rompono prima, ma contano di più
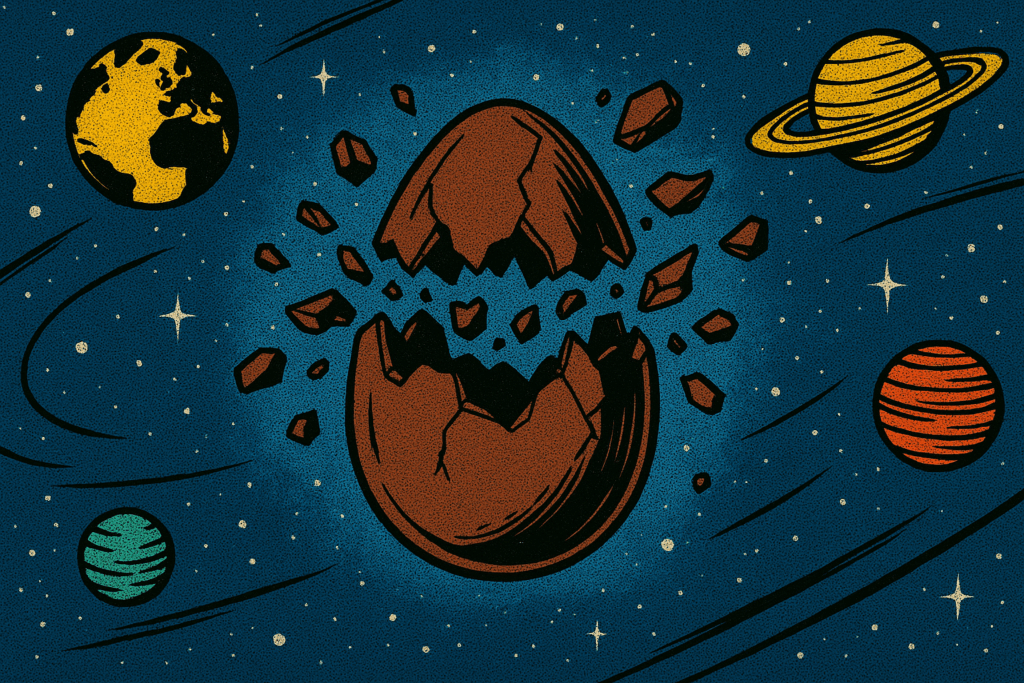
Oggi, nell’epoca dei sistemi distribuiti, delle applicazioni web e delle piattaforme cloud-native, ci rendiamo conto che “funzionare” è solo il primo strato dell’essere. Spesso è il meno interessante.
Una piattaforma di pagamento che funziona ma non è sicura è una minaccia, non un progresso. Un’app di messaggistica che non regge il carico è come un telefono muto.
Nel mondo dell’informatica contemporanea, dominato da nuvole (che non piovono) e intelligenze (che ancora sbagliano le tabelline), emergono termini come “latency”, “availability”, “resilience”. Sono concetti tecnici, certo, ma dietro di essi si cela una verità più ampia: ciò che non si vede è spesso ciò che regge tutto. Il telaio dietro l’arazzo.
Ed è un errore semantico, prima ancora che concettuale, chiamare questi attributi “non funzionali”. È come se l’architetto di un ponte ignorasse il vento solo perché invisibile.
Il ritorno del tasto “ON”
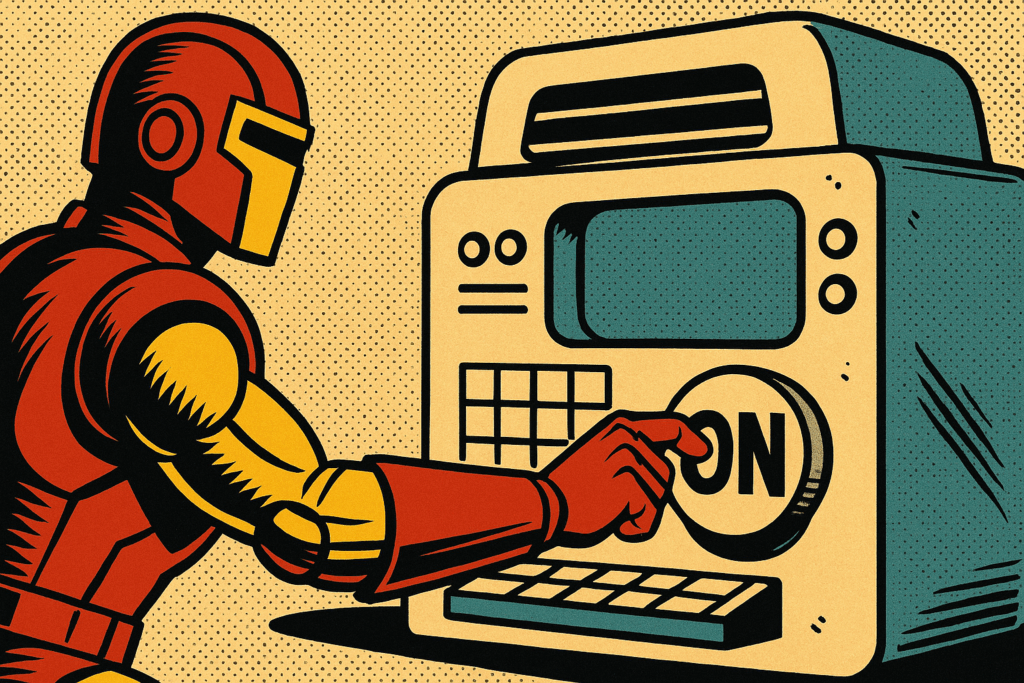
Negli anni Ottanta bastava un gesto: premere ON. E qualcosa succedeva. L’azione produceva reazione e la reazione era spesso accompagnata da un suono analogico che diceva: “ci sono”. Era l’era della relazione lineare tra causa ed effetto.
Oggi, premere ON è solo l’inizio di una catena invisibile di dipendenze e condizioni: DNS, cache, API, microservizi, container.
Ogni click è un’evocazione complessa che si affida a infrastrutture globali, bilanciamenti di carico, autenticazioni a più fattori. L’illusione del controllo è sostituita dalla delega automatica.
Eppure, continuiamo a comportarci come negli anni ’80: “Funziona? Bene”. Ma oggi serve una seconda domanda: “Funziona per chi? Funziona sempre? Funziona quanto basta?”
Da nuovi superpoteri…
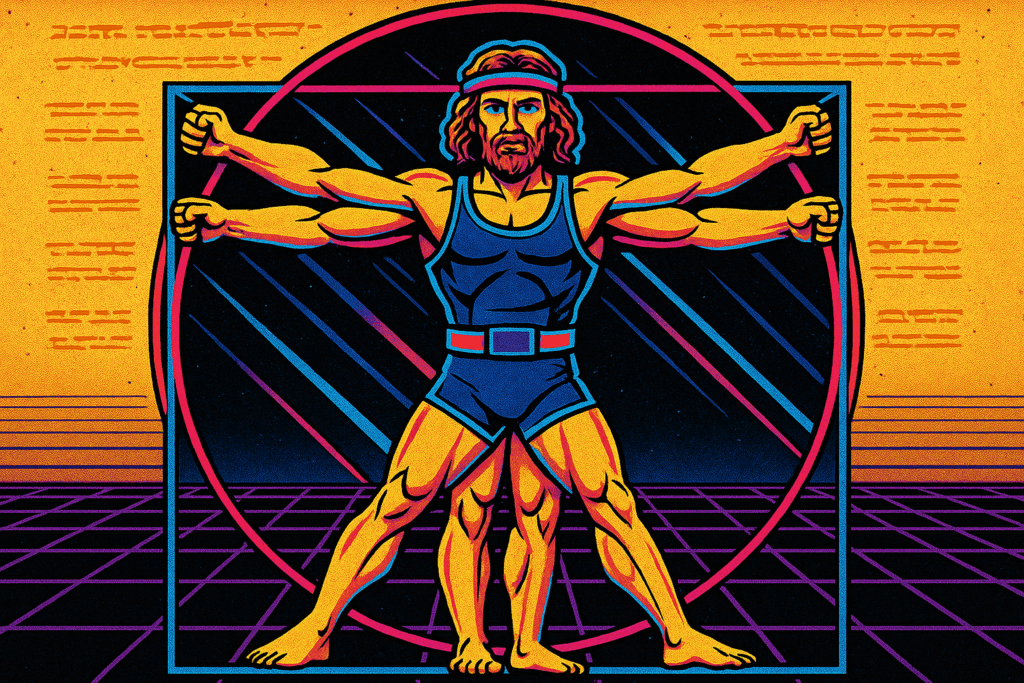
Così come Vitruvio parlava di “firmitas”, “utilitas” e “venustas”, anche chi progetta software deve pensare non solo a cosa fa un’applicazione, ma a come, per chi, e per quanto tempo.
Le cosiddette “-ilities” – come scalability, observability, maintainability, security – non sono orpelli. Sono fondamenta. Eppure restano fuori dai contratti, dagli obiettivi, dai PowerPoint.
Serve quindi una cultura nuova, in cui l’architetto software non sia più lo scriba tecnico che disegna flussi, ma il custode di un equilibrio invisibile, dove ogni requisito “non funzionale” è in realtà un patto sociale tra chi crea e chi usa.
Coding Elvis?
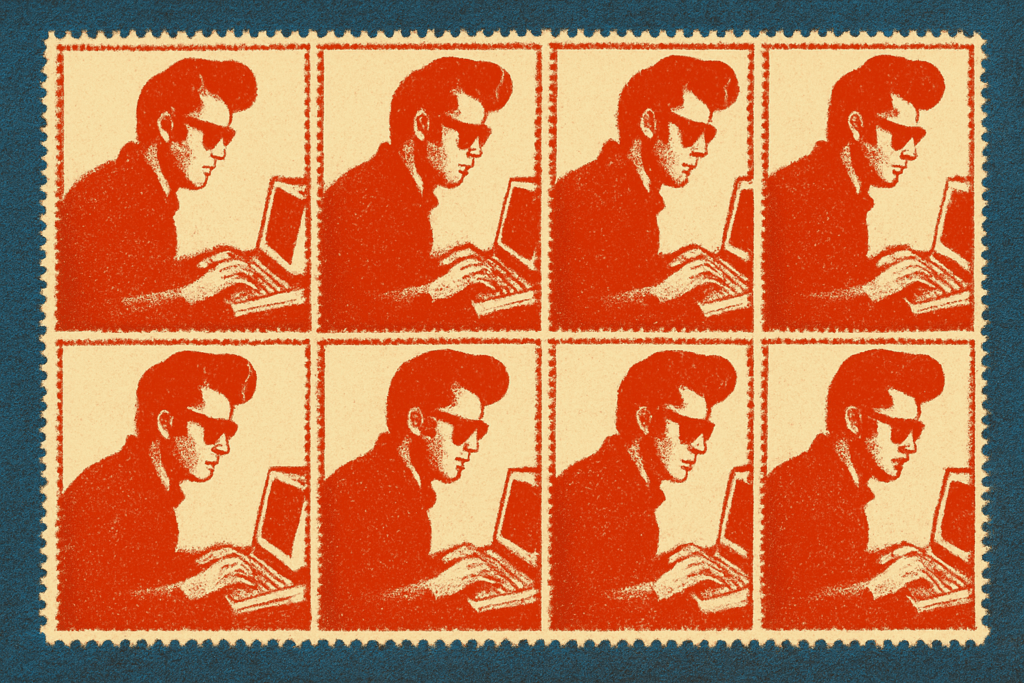
In questo contesto è nato un nuovo paradigma: il Vibe Coding. Un termine leggero, quasi da t-shirt di startup, che però cela un cambiamento radicale. Non si scrive più codice: si descrive l’intenzione. Si lancia una richiesta nell’etere semantico dell’Intelligenza Artificiale, e si spera che il codice giusto emerga.
Andrej Karpathy, ex direttore dell’intelligenza artificiale di Tesla e cofondatore di OpenAI, lo dice senza vergogna: “Vedi qualcosa, dici qualcosa, incolli qualcosa. Funziona”. Ma davvero? O siamo tornati all’ON degli anni Ottanta, solo con meno comprensione?
Il Vibe Coding potrebbe essere il nuovo click del telecomando a infrarossi: semplice, comodo, più o meno soddisfacente. Ma se non ci chiediamo come funziona e perché dovrebbe essere affidabile, non stiamo progettando: stiamo “vibrazionando” a caso.
Don’t FOR-GET to RE:MEMBER
Gli anni Ottanta ci hanno lasciato la fascinazione per la funzione visibile. L’era contemporanea ci impone di riscoprire una qualità invisibile. Se ieri bastava che qualcosa accadesse, oggi dobbiamo sapere come, per quanto e con quali garanzie.
Il Vibe Coding, l’AI, il design moderno non ci esonerano dalla responsabilità. Al contrario, ci chiedono più consapevolezza. Ci ricordano che nel codice, come nella vita, ciò che conta davvero non è ciò che appare, ma ciò che regge.
Forse, come diceva Borges, il futuro è già passato. Ma possiamo ancora scegliere se vivere tra le rovine di un software fragile o tra le cattedrali invisibili della qualità ben progettata.